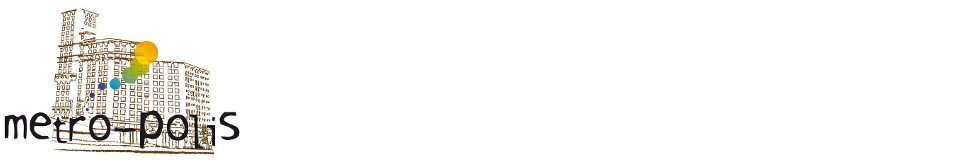Immagino questo spazio come l’occasione per parlare ogni mese di un libro. Non di un libro semplicemente letto, ma di un libro che sento di aver, per qualche motivo, profondamente vissuto. Non ho certamente l’ambizione di scrivere recensioni di testi che in molti casi sono già unanimemente considerati dei pilastri della letteratura, ma di cercare di esprimere cosa ci ho trovato, di far emergere gli elementi che più mi hanno fatto riflettere, quali emozioni mi hanno suscitato, provando così a mescolare il piano oggettivo della storia raccontata con il suo piano soggettivo e magari incuriosendo chi in quel volume non è ancora “inciampato”. Credo che, in fondo, ogni libro sia non solo il prodotto del suo autore, ma anche di chi lo legge.
Raramente scelgo un libro scorrendone prima la trama. Mi lascio piuttosto affascinare dal suo titolo o, in modo assai più superficiale, dalla sua copertina, cercando di non farmi influenzare dalle opinioni comuni che lo accompagnano, sia esso considerato un “classico” o meno. Questo per non rovinarmi la sorpresa dei suoi contenuti, ma permettermi al contrario di stupirmi e, in alcuni casi, anche di farmi portare fuori strada. Credo che sia stato questo il motivo per cui ho a lungo rimandato la lettura di Cent’anni di solitudine, un titolo (diciamolo pure) di per sé non particolarmente accattivante o promettente, che mi faceva pensare a una storia deprimente e stilisticamente pesante. Quando ho finalmente deciso di iniziare la lettura, perché sentivo che era venuto il momento, mi sono immediatamente resa conto di quanto fossero sbagliati i miei pregiudizi. Ma, forse, è stato proprio il fatto di ritrovarmi davanti a una storia del tutto diversa da come me l’aspettavo che mi ha completamente rapita e affascinata.
Anche solo tentare di riassumere i fatti di questa storia così complessa e surreale è un compito non facile. Le vicende e le avventure delle diverse generazioni della famiglia Buendía, i cui capostipiti José Arcadio e Ursula sono tra i fondatori dell’immaginaria cittadina di Macondo, si susseguono a un ritmo vertiginoso e incalzante, non lasciando al lettore neppure una pausa per riprendere fiato. Sono bastati pochi capitoli per farmi venire in mente un’immagine ben precisa che riesce per me, più di ogni parola, a dare un’idea della storia: l’immagine di una giostra.
Le generazioni della famiglia Buendía si susseguono una dopo l’altra, ma ogni volta i nuovi personaggi ripercorrono le stesse orme dei loro predecessori, girando come in un circolo, senza sosta, e ritrovandosi costantemente al punto di partenza. E quella che all’inizio sembrava solo un’impressione ha trovato conferma verso la fine del libro nei pensieri della stessa Ursula, vero e proprio pilastro dei Buendía che assiste e resiste fino alla fine agli stravolgimenti che si annientano sulla sua famiglia: «Ursula ancora una volta rabbrividì constatando che il tempo non passava, ma che continuava a girare in tondo». Il carattere circolare della storia si riflette anche nei nomi dei protagonisti che si ripetono uguali ogni generazione con tanto di trasmissione, quasi genetica, di uno stesso destino.
Il susseguirsi frenetico dell’azione e l’insieme di vicende al limite del reale rendono il libro una vera e propria fiaba, in cui è possibile ritrovare temi e situazioni comuni alla quotidianità di ogni esistenza. Primo fra tutti il tema della morte, o meglio del rapporto tra vita e morte. La morte grava infatti come uno spettro sui componenti della famiglia Buendía, ma nello stesso tempo non appare come qualcosa di separato dalla vita, ma come un elemento a essa complementare. Ed è così che i fantasmi continuano a far visita ai vivi, parlando con loro come se fossero ancora presenti e continuassero a condividere la sorte di chi è rimasto. E se i morti restano in qualche modo vivi, così alcuni tra i vivi decidono di condurre una vita da morti, rinchiudendosi nella loro solitudine e allontanandosi volontariamente dal mondo che li circonda, come nel caso di Rebeca o del colonnello Aureliano Buendía alla fine della guerra che ha combattuto per lunghi anni.
E proprio la guerra rappresenta un altro elemento centrale del libro: una guerra narrata in modo talmente surreale, attraverso un generico quanto banale scontro tra conservatori e liberali, da far riflettere sul carattere assurdo, e quasi drammaticamente comico, di ogni conflitto. La guerra che solo in alcuni momenti viene concretamente sofferta dai protagonisti resta sempre sullo sfondo come una possibilità sempre presente, sempre aperta, anche quando sembra definitivamente sopita.
Un ultimo aspetto che colpisce è la costante contrapposizione tra l’interno e l’esterno del luogo dell’azione. Finché l’azione si svolge a Macondo, più in generale, e all’interno della famiglia Buendía, nello specifico, sembra essere garantita una qualche soprannaturale protezione. Ma ogni elemento destabilizzante proveniente dall’esterno, sia esso un fatto o una persona, sembra minare le basi della sicurezza e della serenità. E così anche le relazioni al limite dell’incestuoso appaiono in fondo meno pericolose e condannabili delle unioni tra gli esponenti della famiglia Buendía e i personaggi che a quel microcosmo resteranno sempre estranei, come Fernanda. L’unico straniero che rappresenta l’eccezione a questa regola è lo zingaro Melquíades, amico del capostipite José Arcadio, a lungo unico contatto tra Macondo e il mondo esterno, portatore di strambe invenzioni e carte misteriose, il cui contenuto verrà compreso solo anni dopo la sua morte e permetterà infine di comprendere il significato di quei cento anni di solitudine.
Beatrice Collina