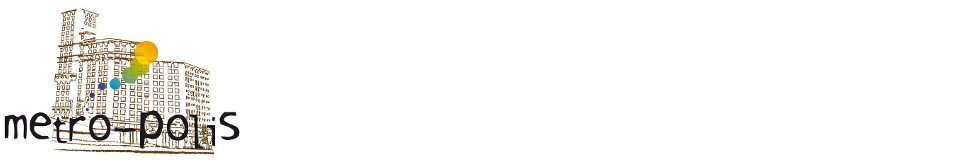di Danila Faenza
Quando la redazione di Metro-Polis mi ha chiesto di scrivere un articolo sul quarantennale del sequestro e dell’omicidio di Aldo Moro ho accettato subito per empatia, per il piacere di scrivere e perché, frequentando giovani per lavoro, mi rendo conto di quanto le generazioni successive alla mia siano davvero povere di memoria storica. E, con questo termine, mi riferisco non solo alle negligenze della scuola (spesso chiamata in causa a sproposito), ma a quella “memoria” acquisita che si crea col dialogo in famiglia, attraverso il ricordo che scatta commentando un fatto di cronaca, guardando un film, chiacchierando col nonno o con la zia.
 E allora mi sono resa conto di quanto sia difficile comunicare efficacemente un evento storico che, per molti di noi, fu traumatico nonostante – e sottolineo nonostante – il clima.
E allora mi sono resa conto di quanto sia difficile comunicare efficacemente un evento storico che, per molti di noi, fu traumatico nonostante – e sottolineo nonostante – il clima.
Ci provo, consapevole di entrare in una macchina del tempo che, per molti aspetti, ci riporta in un altro mondo: diciamo che a parte la nebbia in Val Padana, il gossip su Al Bano e Romina e le invettive contro il governo (qualsiasi esso sia) era tutto diverso. Non sto a dilungarmi sulle differenze di comunicazione: nessun internet, nessun social: esisteva ancora il duplex, telefono fisso che collegava due abitazioni diverse a prezzo scontato; se dovevi telefonare in un’altra città c’era la tariffa interurbana, a causa della quale i genitori, appena ricevuta la bolletta del telefono (che era rigorosamente documentata, con numeri, orari e durata) ti facevano un mazzo tanto perché avevi chiamato l’amica di Modena o il filarino di Salerno (e la distanza, in questo caso, si pagava a caro prezzo, perché la bolletta saliva proporzionalmente alla distanza geografica).
Insomma, sto parlando del paleolitico, era in cui si sfogliavano i giornali per informarsi, si guardava la televisione per acculturarsi, si leggeva per conoscere e si studiava per sapere.
In tutto questo, l’Italia era un Paese altamente conflittuale: scioperi continui, manifestazioni, operai contro “padroni”, studenti contro tutti, polizia armata che spesso uccideva “per sbaglio”.
Da una parte le Destre e le loro derive terroristiche e stragiste, dall’altra le Sinistre con le loro derive extraparlamentari e terroristiche. E, in mezzo, la Democrazia Cristiana, partito conservatore che era garanzia per tutti quelli che avevano paura dei comunisti (vi ricorda qualcosa? All’epoca i comunisti c’erano ancora, almeno di nome), dei cambiamenti minimi (il divorzio, per esempio, che era già stato approvato, udite, udite, con un referendum), delle femministe che riempivano le piazze con le loro rivendicazioni, di nuove identità sociali appoggiate dal Partito Radicale (le prostitute, gli omosessuali, le persone transessuali, i detenuti, coloro che sostenevano la liberalizzazione delle droghe leggere – e siamo ancora lì, dopo quarant’anni…).
 Ecco, in tutto questo casino, difficile da descrivere, si inserirono dei gruppi terroristici cosiddetti “di sinistra”, nuclei di persone che pensarono che le loro azioni sanguinarie potessero portare a una rivoluzione; peccato che le rivoluzioni (la storia lo insegna) siano fatte di sangue ma anche di partecipazione popolare. Bene: le Brigate Rosse, Prima Linea e tutti gli altri gruppi terroristici non ebbero nessun supporto dal cosiddetto “proletariato urbano”: nessuno, se non i loro stessi adepti, ebbe mai una parola di comprensione verso le loro azioni, nessuna manifestazione in loro supporto.
Ecco, in tutto questo casino, difficile da descrivere, si inserirono dei gruppi terroristici cosiddetti “di sinistra”, nuclei di persone che pensarono che le loro azioni sanguinarie potessero portare a una rivoluzione; peccato che le rivoluzioni (la storia lo insegna) siano fatte di sangue ma anche di partecipazione popolare. Bene: le Brigate Rosse, Prima Linea e tutti gli altri gruppi terroristici non ebbero nessun supporto dal cosiddetto “proletariato urbano”: nessuno, se non i loro stessi adepti, ebbe mai una parola di comprensione verso le loro azioni, nessuna manifestazione in loro supporto.
Erano soli, come i matti che credono di essere Napoleone.
Rapivano, ferivano, uccidevano persone a caso. Anzi no: nei loro deliranti pensieri non erano soggetti “a caso”, ma elementi di “disturbo”, complici in piani che solo loro potevano individuare nel loro delirio.
Tutto questo per dire che, all’epoca, un rapimento, un omicidio, un ferimento, era all’ordine del giorno.
Dopo l’11 settembre del 2001, la parola d’ordine è: «quel giorno ha cambiato la vita di tutti». Non è vero: avrà cambiato la vita degli statunitensi, ma non la nostra. La nostra vita – di italiani, di europei – cambiò negli anni ’70, anni in cui non sapevi davvero se andando al lavoro saresti tornato a casa, se manifestando per un diritto non saresti stato colpito da una pallottola della polizia, se salendo su un treno saresti arrivato a destinazione, se scrivendo un articolo “antipatico” nessuno ti avrebbe sparato.
Questa era l’atmosfera di quegli anni, a confronto dei quali la distruzione di una biblioteca per il semplice fatto che vengano messi dei tornelli per impedire a spacciatori e balordi di disturbare l’attività di chi è lì per studiare appare davvero incomprensibile e pretestuosa.
 Ma nonostante il quotidiano bollettino di guerra, il rapimento Moro fu un trauma per tutti, anche per chi, come me e per la maggior parte dei miei amici, non nutriva nessuna simpatia per la Democrazia Cristiana né per il suo presidente: i terroristi avevano mirato troppo in alto e la sensazione generale era di paura, quella paura che era proprio lo scopo del terrorismo.
Ma nonostante il quotidiano bollettino di guerra, il rapimento Moro fu un trauma per tutti, anche per chi, come me e per la maggior parte dei miei amici, non nutriva nessuna simpatia per la Democrazia Cristiana né per il suo presidente: i terroristi avevano mirato troppo in alto e la sensazione generale era di paura, quella paura che era proprio lo scopo del terrorismo.
Un agguato militare, con l’uccisione di tutta la scorta: i carabinieri Oreste Leonardi e Domenico Ricci, i poliziotti Raffaele Iozzino, Giulio Rivera e Francesco Zizzi, nomi troppo spesso dimenticati.
Per dire quanto l’evento rimase nella memoria, proprio il 16 marzo scorso, un amico mi ha mandato un messaggio in cui chiedeva se mi ricordavo che, quarant’anni prima, eravamo insieme a casa mia incollati davanti alla tv per seguire i servizi che si susseguivano senza sosta.
Proprio il mio amico Graziano mi ha rammentato del panico che investì un intero Paese, alla notizia che Aldo Moro, uno dei politici più noti nonché tra i padri fondatori della Repubblica, era stato rapito: lui stava assistendo ad una lezione del professor Adriano Prosperi quando un bidello spalancò la porta dell’aula annunciando il rapimento: Prosperi sospese la lezione (come tutti, quel giorno) e salutò gli studenti con un mesto «speriamo che ci permettano di continuare a studiare». Perché immediatamente tutti pensarono ad un colpo di Stato, evento certo non così improbabile, all’epoca (se ne erano tentati e progettati altri). Graziano corse a casa mia: mi svegliò, mi raccontò quello che era successo e il resto della giornata lo passammo così, davanti alla televisione, tra paura, sconcerto, senso di smarrimento.
E no, non mi ricordavo quel particolare giorno, ma certo ricordo quel periodo, dal 16 marzo al 9 maggio 1978, giornate lunghe e dense di notizie; presto le BR rivendicarono l’attentato e il rapimento, eseguito per sottoporre l’onorevole Moro a un delirante “processo del popolo”: peccato che “il popolo” non solo non avesse chiesto nulla alle Brigate Rosse, ma non perdesse occasione per affollare le piazze di manifestazioni contro quella violenza, contro quello sparuto gruppo di persone che avevano deciso di parlare a nome suo del tutto arbitrariamente.
Furono 55 giorni di comunicati via via sempre più preoccupanti, di ricerche continue, false piste, sedute spiritiche, discussioni tra le due fazioni delle “colombe” (che erano disposte a trattare coi terroristi, che richiedevano la liberazione dei loro membri incarcerati) e dei “falchi” (contrari ad ogni trattativa e, in certi casi, come quello dell’onorevole Ugo La Malfa, favorevoli al ripristino della pena di morte). Laghi dragati, nascondigli abbandonati, appelli accorati di Papa Paolo VI, amico personale di Moro, tentativi di dialogo coi cosiddetti “compagni che sbagliano” da parte di Marco Pannella, posti di blocco ovunque, inasprimento dei controlli polizieschi.
Niente, niente servì a salvare la vita di un uomo che, stando alle lettere che inviava dalla prigionia, era moralmente e fisicamente esausto. Niente, nemmeno una Roma ormai militarizzata che controllava chiunque riuscì a impedire che qualcuno parcheggiasse indisturbato una comunissima Renault rossa in via Caetani, simbolico luogo posto tra la sede del Partito Comunista e quella della Democrazia Cristiana, i “grandi” colpevoli. Niente evitò l’ultima, enorme umiliazione di un uomo che aveva conosciuto il potere: il suo corpo senza vita, accartocciato nel baule di quell’auto, coperto da un plaid.
Ed è bene insistere, su quel niente, perché a distanza di decenni, faticosamente e con molti silenzi, tante omissioni e tanti segreti (chiusi probabilmente più nelle menti di qualcuno che non in un “armadio degli orrori”) sono emersi fatti, testimonianze e strane “coincidenze” che, in parte, riscrivono quella storia con la mano di complicità impensabili, concertazioni macabre, accordi indicibili. E, se mai si arriverà alla conferma di una storia riscritta, sarà chiaro che quel “niente” era volontà precisa di molti.