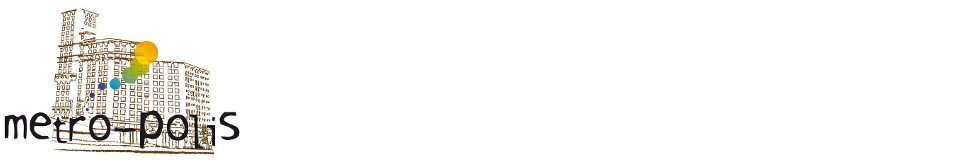Introduzione
Ancora oggi, la letteratura viene erroneamente percepita come una dimensione astratta, distante, difficilmente assimilabile alla complessità del presente, forse poiché troppo ancorata al proprio passato o forse perché troppo appartenente alla sfera referenziale del suo autore. Questa rubrica vuole ricordare come una macrocategoria ampissima e multidimensionale quale la letteratura possa essere nuovamente rivisitata come chiave del contemporaneo, come strumento privilegiato per creare molteplici ponti tra passato e presente, generando riflessioni utili per muoversi con dimestichezza e con maggiore consapevolezza nella complessità della società contemporanea.
Un romanzo un pò antiquato come Cristo si è fermato ad Eboli, pietra miliare di Carlo Levi, pubblicato da Einaudi nel 1945 e ormai dimenticato nelle antologie scolastiche o in fondo ai ripiani delle nostre librerie, rappresenta un chiaro esempio di come esista ancora oggi moltissimo di attuale nella letteratura, tracciando vecchi e nuovi universali riconducibili alle problematiche odierne.
I nuclei tematici di questo libro sono numerosi tra cui l’interdizione della libertà di parola e pensiero, le stupefacenti differenze tra nord e sud, la scoperta di culture incomprensibili e l’oscura presenza (o meglio assenza) dell’emigrazione italiana nel mondo. Ecco che il punto di partenza sarà proprio il fenomeno migratorio; come sfondo del villaggio fantasma di Gagliano, arroccato sui colli argillosi della Lucania del 1934, letteralmente svuotato dei suoi uomini emigrati all’estero, in parallelo con un’Italia contemporanea in crisi e che perde sempre più giovani, proprio come il secolo precedente.
Emigrazione: un pò di numeri
Tradizionalmente, l’Italia è considerata il prototipo di “terra di emigranti” per eccellenza. Milioni di italiani, infatti, hanno abbandonato il proprio paese, specialmente tra la fine del XIX secolo alla Prima guerra mondiale, per poi riprendere a partire nel Secondo dopoguerra fino agli anni ‘70 e ricominciare alle soglie degli anni 2000.
Oggigiorno, gli italiani nel mondo costituiscono un gruppo etnico significativamente importante, non solo da una prospettiva strettamente numerica ma soprattutto da un punto di vista socioculturale, economico e politico. A metà dello scorso anno, i cittadini italiani iscritti all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) risultano 4.408.640, ripartiti prevalentemente tra Europa (54,3%), America settentrionale (9,1%) e meridionale (30,9%), e Oceania (5,4%). Il numero complessivo di cittadini italiani residenti all’estero, che rappresenta oggi quasi il 7% della popolazione italiana residente in Italia, è aumentato di oltre 2.000.000 unità rispetto a soli dieci anni fa; un dato che sembra essere correlato a fenomeni storici quali trasformazioni sociali e culturali precisi di cui quello più rilevante sembra essere la crisi economica degli anni Duemila.
Le nuove ondate migratorie italiane degli ultimi decenni rappresentano dinamiche molto diverse rispetto al passato; la nuova emigrazione italiana, infatti, si sovrappone quasi interamente alla cosiddetta “fuga dei cervelli”, ovvero l’espatrio di giovani altamente istruiti e professionalmente qualificati.
Secondo i dati dell’ISTAT, all’inizio degli anni 2000 il numero dei laureati italiani emigrati nel mondo erano circa 3.800; nel 2005 erano quasi 5.000 e alla fine del decennio oltre 6.200, più del doppio di dieci anni prima. Nel corso di un solo decennio sono stati quindi oltre 51.000 i laureati italiani che hanno abbandonato il nostro paese. Le statistiche confermano la tendenza delle migrazioni verso le grandi economie internazionali, così che progressivamente, molti paesi meno economicamente vincenti si stanno svuotando di moltissime menti brillanti e l’Italia sembra essere uno dei maggiori protagonisti (forse inconsapevole) di questo processo.
Secondo l’AIRE, sono più di 4 milioni i cittadini italiani distribuiti su tutto il mondo; una cifra cospicua alla quale si devono aggiungere anche gli oriundi italiani, ovvero coloro che si riconoscono etnicamente italiani per discendenza, arrivando così (secondo le stime del CEI) addirittura a 58 milioni; considerando che la popolazione italiana conta circa 60 milioni di persone possiamo affermare che tra i nostri connazionali che vivono all’estero e i loro discendenti esiste un’altra Italia al di fuori dell’Italia stessa.
Il mito (e l’antimito) dell’emigrazione
Per delineare un ponte tra le grandi emigrazioni di massa del passato e la loro attualizzazione contemporanea, l’insieme dei valori, dei significati e delle aspettative che, più sul piano astratto che su quello fisico, ruotavano attorno alla meta d’arrivo, costituivano un punto fondamentale nella dinamica emigratoria. Nella coscienza collettiva, paesi eterogenei ad alta immigrazione italiana come gli Stati Uniti, il Canada, l’Argentina e, successivamente, l’Australia, furono ricondotti nell’immaginario migrante a lungo sotto l’ampissima categoria di America; il termine-simbolo onnicomprensivo che, parzialmente ancora oggi, esula dai confini geografici e racchiude in sé tutta l’America del Nord o del Sud e talvolta addirittura l’Oceania, forse per la distanza o per l’affinità linguistica, il luogo di arrivo e di sogno, di realizzazione economica e sociale. Tale continente mitico, più immaginario che reale, è stato considerato a lungo come la terra delle opportunità per eccellenza, la meta dove emigrare per fare fortuna, fuggendo dalla miseria e dall’indigenza in cui versavano migliaia di contadini italiani nel secolo scorso. I racconti e le testimonianze erano raccolti dagli emigrati, da leggende popolari o dalle stesse compagnie d’emigrazione.
Nel corso del XIX secolo, si cominciò dunque ad affermare nell’immaginario collettivo italiano ed europeo un inconsapevole American Dream, ovvero il sogno che attraverso il duro lavoro, sacrifici e determinazione, fosse possibile conquistare un tenore di vita migliore, incrementando socialmente il proprio status all’interno della nuova società. Per quanto rischiosa e spesso mendace, tale aspirazione rimaneva una speranza fondamentale per gli immigrati stranieri in cerca di un riscatto sociale nel Nuovo Mondo.
Fin dalla scoperta del continente nordamericano, la frenesia per il successo economico ha suscitato ampie critiche da parte dell’opinione pubblica europea in quanto, ancora oggi, la società americana continua a enfatizzare il benessere materiale come unico sinonimo di felicità e realizzazione personale, un edonismo sociale facilmente discutibile che si scontra con il sogno americano illusorio che, come la storia ci ha mostrato, ha molto spesso imprigionato l’immigrato nell’indigenza e nell’emarginazione.
Ma da cosa nasce il sogno dell’emigrazione? Per secoli, il Nuovo Mondo (a cui possiamo ricondurre l’America tanto settentrionale quanto meridionale) si presentava come un paese nettamente contrapposto ai modelli sociali, politici ed economici europei caratterizzati da un profondo immobilismo sociale e istituzionale, da un rigido conservatorismo politico e, per molto tempo, da una grande arretratezza agricola e industriale. Un territorio sconfinato, libero, scarsamente popolato e ricco di risorse (a lungo molte delle risorse naturali, agricole, industriali erano libere e generarono promesse di proprietà terriere a poco prezzo; è da ricordare inoltre il cosiddetto Gold Rush americano ovvero la corsa all’oro a metà dell’800), si presentava quindi come il posto privilegiato per la mobilità sociale verso l’alto dei suoi cittadini e per l’affermazione del proprio benessere.
L’Italia, che antiteticamente si presentava come il “paese della fame”, proiettava verso l’America la parvenza di una terra edenica, della prosperità e dell’abbondanza. Opulenza economica e dunque alimentare che ebbe profonde conseguenze anche sul piano fisico degli stessi emigrati italiani; molti studiosi si sono soffermati sulle apparenze dei discendenti italiani all’estero, osservando che molti di essi furono soggetti a una sorta di mutamento antropologico, così che altezza, robustezza, grossezza sono i segni più tangibili del nuovo status degli americani, del loro sentirsi appartenenti a una categoria sociale diversa da quella di appartenenza. Questi caratteri antropologici e psicologici degli emigrati partiti e/o ritornati rivelavano una diversa condizione economico-sociale e quindi il raggiungimento di nuovi standard di ricchezza e auto-affermazione.
Se da una parte il successo di questo mito è dovuto alle condizioni economico-politiche degli ultimi due secoli, dall’altra è anche vero che il mito dell’America possiede radici profonde specificatamente nell’inconscio italiano. Forse i richiami ancestrali ai tragitti mitici di Cristoforo Colombo e la sua scoperta del Nuovo Mondo, i viaggi degli esploratori Amerigo Vespucci, Giovanni e Sebastiano Caboto o Giovanni da Verrazzano, ecc. crearono nell’immaginario italiano una sorta di rivendicazione inconscia per quei territori di fortuna.
Tuttavia, il sogno americano, costellato da contenuti mitici avventurosi e da chimeriche ambizioni di ricchezza e prosperità, nascondeva in esso anche un lato oscuro. L’emigrazione veniva percepita, spesso indirettamente e solo nella propria sfera più personale, come un evento luttuoso e angosciante, permeato dall’insicurezza e dalle difficoltà delle politiche emigratorie; l’allontanamento dal rassicurante mondo contadino di appartenenza per un cammino in bilico tra l’incertezza e lo straniamento linguistico, sociale e culturale; uno stato emotivo che è possibile ricondurre alla categoria dell’unheimlich freudiano. Con l’emigrazione si consumava, infatti, un distacco traumatico alla comunità familiare e paesana, un taglio netto a quelli che erano gli affetti e i soli riferimenti culturali e punti di riferimento dell’emigrato. La partenza verso l’ignoto e senza ritorno attraverso un viaggio che fino alla Seconda guerra mondiale si conduceva esclusivamente su acqua, segnava profondamente l’esperienza dell’emigrazione.
Cristo si è fermato ad Eboli: i fantasmi dell’emigrazione
 L’America, poi, rappresentava e rappresenta ancora oggi il paese della modernità, della civiltà materialista, industriale, tecnocrate, della disgregazione e del liberismo; di contro l’Europa simboleggiava la civiltà, la storia, la tradizione millenaria dei valori culturali consolidati in tutto l’Occidente. Numerose immagini eccezionalmente espressive di questo contrasto quasi “mitico” sono riscontrabili nel romanzo autobiografico Cristo si è fermato ad Eboli di Carlo Levi, pubblicato ormai quasi ottant’anni fa eppure estremamente attuale. Nel 1935, Levi, giovane medico torinese fermamente antifascista, venne condannato dal regime al confino presso il piccolo villaggio di Gagliano arrampicato sui colli argillosi della Lucania. All’interno di questo microcosmo, estraneo ed ostile, Levi si ritrova espatriato; ed ecco che, parallelamente alla conduzione di un’esperienza tanto umana quanto antropologica, viene a delinearsi il ritratto di una civiltà millenaria, sorretta nel proprio immobilismo, inconciliabile con il mondo moderno. Lasciata da parte, dimenticata dall’Italia intera e dalla sua classe dirigente, Gagliano si configura come una terra sterile popolata unicamente da vedove interamente vestite di nero (forse non così dissimili dai minacciosi burqa contemporanei) e dai fantasmi degli uomini emigrati oltreoceano, disertori di un paese miserrimo e contradditorio che li aveva abbandonati alla fame privandoli dei propri sogni.
L’America, poi, rappresentava e rappresenta ancora oggi il paese della modernità, della civiltà materialista, industriale, tecnocrate, della disgregazione e del liberismo; di contro l’Europa simboleggiava la civiltà, la storia, la tradizione millenaria dei valori culturali consolidati in tutto l’Occidente. Numerose immagini eccezionalmente espressive di questo contrasto quasi “mitico” sono riscontrabili nel romanzo autobiografico Cristo si è fermato ad Eboli di Carlo Levi, pubblicato ormai quasi ottant’anni fa eppure estremamente attuale. Nel 1935, Levi, giovane medico torinese fermamente antifascista, venne condannato dal regime al confino presso il piccolo villaggio di Gagliano arrampicato sui colli argillosi della Lucania. All’interno di questo microcosmo, estraneo ed ostile, Levi si ritrova espatriato; ed ecco che, parallelamente alla conduzione di un’esperienza tanto umana quanto antropologica, viene a delinearsi il ritratto di una civiltà millenaria, sorretta nel proprio immobilismo, inconciliabile con il mondo moderno. Lasciata da parte, dimenticata dall’Italia intera e dalla sua classe dirigente, Gagliano si configura come una terra sterile popolata unicamente da vedove interamente vestite di nero (forse non così dissimili dai minacciosi burqa contemporanei) e dai fantasmi degli uomini emigrati oltreoceano, disertori di un paese miserrimo e contradditorio che li aveva abbandonati alla fame privandoli dei propri sogni.
Ecco che quindi, all’interno di quest’opera, un vero e proprio viaggio antropologico nelle profondità di uno spaccato culturale, sociale e politico così remoto eppure attualissimo, il tema dell’emigrazione, benché fisicamente assente risulti, per contro, onnipresente. I contadini lucani di Levi sono lacerati da un’immagine ambivalente dell’America; essa è la terra del lavoro e dei sacrifici, del denaro risparmiato faticosamente, dell’insofferenza e della rabbia, il luogo dove “qualche volta si muore e nessuno più ci ricorda”; ma nello stesso tempo è anche “il paradiso, la terra promessa”.
Questo svuotamento umano, di uomini e manodopera giovane, ma anche culturale, la minaccia della perdita, dell’oblio della propria cultura, ha segnato profondamente la comunità locale;
“L’emigrazione ha cambiato tutto. Gli uomini mancano e il paese appartiene alle donne. Una buona parte delle spose hanno il marito in America. Quello scrive il primo anno, scrive ancora il secondo, poi non se ne sa più nulla, forse si fa un’altra famiglia laggiù, certo scompare per sempre e non torna più. Gagliano ha milleduecento abitanti, in America ci sono duemila gaglianesi. In paese ci restano molte più donne che uomini: chi siano i padri non può più avere un’importanza così gelosa: il sentimento d’onore si disgiunge da quello di paternità: il regime è matriarcale. Nelle ore del giorno, che i contadini sono lontani, il paese è abbandonato alle donne, queste regine-uccelli, che regnano sulla turba brulicante dei figli.”
Dietro a queste donne corvo incombono i fantasmi degli emigranti, uomini assenti, mariti, figli, parenti, che in qualche modo fanno sentire la propria presenza nell’umidità delle terre gaglianesi attraverso oggetti, lettere, e la paccottiglia spedita via acqua, custodite gelosamente come reliquie. Ecco che nella miseria paesana così scavata nella propria miseria, quasi comicamente, i segni della modernità arrivati da chissà dove si riscontrano, impercettibilmente.
“Soltanto la posta porta continuamente qualcosa che viene di laggiù, che i compaesani fortunati mandano a regalare ai loro parenti. […] Arrivavano forbici, coltelli, rasoi, strumenti agricoli, falcetti, martelli, tenaglie, tutte le piccole macchine della vita comune. La vita di Gagliano, per quello che riguarda i ferri dei mestieri, è tutta americana, come lo è per le misure: si parla, dai contadini, di pollici e di libbre piuttosto che di centimetri o di chilogrammi. Le donne, che filano la lana su vecchi fusi, tagliano il filo con splendidi forbicioni di Pittsburg. Nessuno sente alcuna prevenzione contro questi strumenti moderni, né alcuna contraddizione fra di essi e i loro antichi costumi. Prendono volentieri quello che arriva da New York, come prenderebbero volentieri quello che arrivasse da Roma. Ma da Roma non era mai arrivato nulla.”
E l’altra immagine che si delinea in questo paese fantasma è l’ombra di uno stato che c’è ma che non si vede, che pretende eppure non offre. Lo stato italiano è nemico. Estraneo, crudelmente indifferente alle dinamiche periferiche della penisola, tanto da alimentare esso stesso il sogno di fuga dei suoi abitanti. “Non Roma o Napoli, ma New York sarebbe la vera capitale dei contadini di Lucania, se mai questi uomini senza Stato potessero averne una. E lo è, nel solo modo possibile per loro, in un modo mitologico.” Per quelle povere genti del villaggio, lontane dalle istituzioni e dalla classe dirigente, al partito e alle ufficiose patine di uno stato che non rappresenta e non è rappresentato, la terra di emigrazione, seppur così lontana, incomprensibile ma rassicurante nelle proprie fattezze mistiche, si riconfermava come la sola terra promessa che aveva potuto ridare vita al proprio sangue, conservando il proprio patrimonio culturale, ineluttabilmente estinto nelle sterili terre italiane roventi dal sole.
Ottant’anni fa, si offriva così una disillusione amara e potente per lo stato italiano, un governo che dimenticava buona parte dei suoi cittadini e che li spingeva a fuggire per sopravvivere; un’immagine cruda e graffiante che, dalle terre aride della Lucania degli anni ‘30 si ritrova, inconsciamente forse meno intensamente forse con minor crudeltà anche oggi, nelle città italiane meridionali e settentrionali, industrializzate e globalizzate, ove tanti giovani decidono di fuggire, forse non più con la valigia di cartone ma con il proprio laptop, in cerca di qualcosa che il loro stato sembra cieco e sordo ai loro bisogni.
E sul filo di questi sentimenti contrastanti, l’attaccamento alle radici e la fuga verso la modernità, l’assoluta devozione alla terra e il bisogno ancestrale per la libertà e l’auto-affermazione che da qualche parte sarebbe stata misticamente raggiunta, ecco che nelle case gaglianesi Levi racconta come si poteva ritrovare accanto al ritratto della Madonna, “la feroce e spietata, oscura dea arcaica della terra, la signora saturniana di questo mondo” simbolo del cristianesimo popolare italiano, contraddittoriamente materno e selvaggio, impregnato di echi pagani antichissimi accanto alla foto del presidente americano Roosevelt, “una specie di Zeus, il dio benevolo e sorridente, il padrone dell’altro mondo”.
NOTE (Riferimenti bibliografici)
C. Levi, Cristo di è fermato a Eboli, Milano, Mondadori, 1964.
P. Bevilacqua, Storia dell’emigrazione italiana, Donzelli, Roma, 2003.
I dati presentati sono consultabili sui siti ufficiali dell’ISTAT, AIRE, Audience Italica nel Mondo, Associazione Internazionale per la Cultura Ambientale e il Lavoro Solidale (AIKAL) e da Chiesa Cattolica (CEI).
Emanuele Gaiba