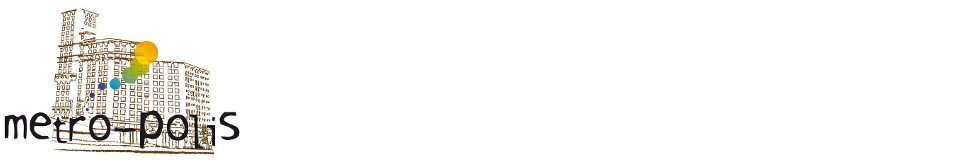di Angelo Errani
Parte I – Normalità e Differenze: ma che cos’è la normalità?
Parte III – La rappresentazione della disabilità. Antichità e Medio Evo
Parte IV – La rappresentazione della disabilità. Età moderna e contemporanea
La follia nell’età della ragione
«La follia […] è un male molto al di là della mia scienza».
(Shakespeare, Macbeth, atto V, scena I, il medico a proposito di Lady Macbeth)

L’età della ragione vedrà nella follia la sua sconfitta, la sconfitta dell’ordine sociale minacciato dal venir meno degli strumenti tradizionali di controllo basati sull’appartenenza. Masse crescenti di migranti dalle campagne, uomini e donne senza più padrone cercano di sopravvivere nelle città, spesso in condizioni di assoluta precarietà. Girovaghi, disabili, mendicanti affollarono le città del Nord Europa, governate da una dinamica e arricchita borghesia. C’è un’immagine che documenta l’ossessione per la minaccia di queste diversità e il tentativo di sbarazzarsene: La nave dei folli di Bosch. Mendicanti e disabili, disoccupati e soggetti che vivevano di espedienti, ladri e prostitute, per ordine delle amministrazioni delle città europee, venivano caricati su battelli e affidati a mercanti che, dietro compenso, avevano il compito di portarli lontano, da dove poi immancabilmente sarebbero tornati.
Ma al delirio illusorio dell’espulsione definitiva degli scarti umani si contrappone negli stessi anni e luoghi l’immagine critica di quella nave: con l’Elogio della follia (1509) Erasmo da Rotterdam restituisce il tema della diversità umana alla sua dimensione razionale, riconoscendo alle motivazioni della follia altrettanta legittimità di quelle della ragione. La disabilità perde il significato di mezzo di espiazione e di edificazione e viene ricondotta alla sua natura terrena, ma diventa un problema sociale per le ricche comunità urbane, che vedono nel miserabile un motivo di disordine e un pericolo che deve essere regolamentato. Si è venuto affermando un nuovo riferimento: l’ordine morale fondato sul lavoro.
«[…] gli ufficiali di giustizia debbono […]istituire case di lavoro forzato, nessuno sarà tanto sciocco né vorrà essere tanto dannoso alla comunità da far donazioni a tali mendicanti e da incoraggiarli».
(Sir M. Hale, Discourse, Touching, Provision for the Poor)
Scopriamo con sorpresa che sono le due realtà europee maggiormente distanti sul piano politico e sociale, l’Olanda e la Spagna, caratterizzate, la prima, da una dinamica borghesia e, la seconda, da un regime di monarchia rigidamente conservatore, a offrirci i documenti più interessanti. I pittori olandesi ci introducono nel mondo vivo e concreto del lavoro e della vita della gente nei suoi dettagli più terreni, in cui la tragedia si combina sempre con la commedia. È quella olandese una comunità orgogliosa dei propri successi, ma anche attraversata dal timore della loro precarietà che, anche l’ambiente naturale, sempre minacciato dalle acque, contribuiva a tener vivo. Gli obiettivi delle leggi penali e dell’assistenza economica si fusero in un ambizioso programma di controllo e, insieme, di rieducazione. Le case di correzione di Amsterdam, Utrecht, Leida, Anversa, in seguito alle ordinanze delle rispettive municipalità che vietavano l’accattonaggio, raccolsero vagabondi, mendicanti, bambini di strada, disabili. L’etica del lavoro guidava i programmi di rieducazione, tenendo insieme la pedagogia del lavoro, fino a quattordici ore al giorno, con i profitti.
 È in questo contesto che si colloca La cura della pazzia di H. Bosch. La scritta in caratteri gotici Heester shyt die keye ras – myne name is lubber das (maestro tira fuori le pietre, il mio nome è sempliciotto) commenta la scena: un cerasico, con in testa l’imbuto della sapienza, incide il capo di un paziente per estrarne le pietre, motivo presunto della pazzia, ma quel che viene veramente estratto è il denaro dalla borsa del credulone. Nell’orrore di un tempo carico di efferatezze – emblematica è la forca sullo sfondo – e l’incubo di pestilenze e guerre, spunta il comico della beffa. Mentre dai pulpiti i predicatori tenevano viva la paura della morte e i laici si impegnavano ad utilizzare le scoperte della scienza a vantaggio dei loro profitti, il pittore ne racconta il delirio, fino a seppellirli nell’ironia. Come Bosch, anche Bruegel è molto lontano dal modo rinascimentale di rappresentare i corpi che, secondo i canoni dell’arte classica, dovevano essere belli.
È in questo contesto che si colloca La cura della pazzia di H. Bosch. La scritta in caratteri gotici Heester shyt die keye ras – myne name is lubber das (maestro tira fuori le pietre, il mio nome è sempliciotto) commenta la scena: un cerasico, con in testa l’imbuto della sapienza, incide il capo di un paziente per estrarne le pietre, motivo presunto della pazzia, ma quel che viene veramente estratto è il denaro dalla borsa del credulone. Nell’orrore di un tempo carico di efferatezze – emblematica è la forca sullo sfondo – e l’incubo di pestilenze e guerre, spunta il comico della beffa. Mentre dai pulpiti i predicatori tenevano viva la paura della morte e i laici si impegnavano ad utilizzare le scoperte della scienza a vantaggio dei loro profitti, il pittore ne racconta il delirio, fino a seppellirli nell’ironia. Come Bosch, anche Bruegel è molto lontano dal modo rinascimentale di rappresentare i corpi che, secondo i canoni dell’arte classica, dovevano essere belli.
 Gli storpi e La parabola dei ciechi ci propongono scene di vita che dovevano essere abbastanza comuni: gruppi di disabili che si spostavano mendicando di luogo in luogo, il pittore li riprende dall’alto, una modalità che schiaccia i soggetti facendoli apparire più fragili. I ciechi vengono colti nel disorientamento che segue la caduta del soggetto che apre la fila, che li fa sbandare disordinatamente. Uno dei ciechi rivolge lo sguardo vano verso lo spettatore che ne può così cogliere il panico, dovuto al non comprendere le ragioni di quella instabilità improvvisa.
Gli storpi e La parabola dei ciechi ci propongono scene di vita che dovevano essere abbastanza comuni: gruppi di disabili che si spostavano mendicando di luogo in luogo, il pittore li riprende dall’alto, una modalità che schiaccia i soggetti facendoli apparire più fragili. I ciechi vengono colti nel disorientamento che segue la caduta del soggetto che apre la fila, che li fa sbandare disordinatamente. Uno dei ciechi rivolge lo sguardo vano verso lo spettatore che ne può così cogliere il panico, dovuto al non comprendere le ragioni di quella instabilità improvvisa.
 Bruegel sa cogliere la pluralità delle condizioni e dei comportamenti umani, ma col distacco dell’uomo di una delle più ricche città europee, Anversa. Il suo è uno sguardo affettuoso e al tempo stesso ironico verso quella brulicante umanità e la sua quotidianità, in cui si intrecciano il lavoro e la festa, il caos e il grottesco, la commedia e la satira.
Bruegel sa cogliere la pluralità delle condizioni e dei comportamenti umani, ma col distacco dell’uomo di una delle più ricche città europee, Anversa. Il suo è uno sguardo affettuoso e al tempo stesso ironico verso quella brulicante umanità e la sua quotidianità, in cui si intrecciano il lavoro e la festa, il caos e il grottesco, la commedia e la satira.
Un contesto molto diverso è quello in cui vive Diego Velasquez, pittore ufficiale della real famiglia spagnola, di cui ritrae i protagonisti e gli aspetti di vita, senza trascurarne i passatempi e i giochi viventi: nani e buffoni di corte.

Il quattrocento si era chiuso in Spagna con la reconquista, condotta dai re cattolici, che aveva visto la cacciata dalla regione delle comunità musulmane ed ebraiche che vi vivevano da secoli. È assai significativo che le navi che trasportavano gli ebrei verso l’Europa orientale e le Fiandre, dove diedero vita alle comunità sefardite (Sefarad, in ebraico Spagna), levassero l’ancora negli stessi giorni in cui Colombo partiva alla ricerca di una rotta per le Indie. Nello stesso anno veniva pubblicato per la prima volta un dizionario di una lingua parlata, il castigliano, che divenne lingua leader a livello mondiale. La riconquista, la conquista dell’America e la leadership nel campo della comunicazione, disegnano un cambiamento profondo, non limitato ai soli aspetti militari, politici e tecnologici, ma della visione del mondo, del modo di concepire il valore delle persone e della loro vita. L’elaborazione della diversità umana, arricchita dal nuovo campionario offerto dalle popolazioni amerindie, si polarizzò sull’opposizione fra natura e cultura. La teoria poligenetica, secondo la quale i “selvaggi” non discenderebbero da Adamo, ma avrebbero un’origine preadamitica, fornì la giustificazione scientifica della superiorità dell’uomo europeo. Dalle spedizioni venivano portati a corte esemplari di “selvaggi”, pappagalli e piante esotiche per soddisfare la curiosità e per divertire.
Non sorprende dunque la presenza di tanti nani chiamati a intrattenere e divertire principi e infante. Si fornivano in questo modo ai bambini, che sarebbero diventati re e regine, dei sudditi in miniatura che evitassero loro l’imbarazzo dell’altezza e con cui esercitarsi ad imparare a governare gli uomini. È grazie alle biografie curate da José Moreno Villa che disponiamo di notizie riguardanti la vita dei tanti nani, uomini e donne, in servizio presso la corte spagnola: Diego de Acedo, Sebastian de Morra, Antonio de Ingles, Calbazar Francisco Lezcano, Maria Barbola.
Verso l’età contemporanea
Smentendo quell’interpretazione della storia, assai radicata nella cultura occidentale, che vede l’umanità emergere dalla barbarie per conquistare via via nuovi traguardi di civiltà, abbiamo potuto verificare in tutte le comunità umane delle diverse epoche e aree del mondo la compresenza di due linee interpretative della diversità umana, ai cui poli si collocano l’esclusione e la ricerca di una prospettiva inclusiva.
La cultura dell’esclusione sperimenterà nell’età contemporanea un’elaborazione che arriverà, nella sua manifestazione più tragica, al decreto nazista che, nel 1939, avviò il programma di eliminazione delle “vite inutili” e l’uccisione delle persone disabili fu la premessa dell’olocausto.
Contestualmente, a partire dal XVII secolo, si inizia a ipotizzare l’educabilità delle persone disabili. Furono i soggetti con disabilità sensoriale, i ciechi e i sordi, i primi a essere ritenuti capaci di imparare. L’educazione alla comunicazione dei soggetti sordi si sviluppò, dalla metà del 1700, secondo due direttrici tuttora attive: l’apprendimento del linguaggio dei segni, (sperimentato da l’Abbé de l’Epeé) e l’educazione all’oralità che vide l’impegno di J. P. Bonet e J. Rodriguez Pereire e R. Ernaud.

I due approcci, quello segnico e quello oralista, anche se con una storia di contrapposizione ancora attiva, riuscirono a dimostrare che l’impedimento sensoriale non comportava l’esclusione dal pensare, comunicare e poter avere una realizzazione di vita adulta.
L’educazione alla comunicazione dei soggetti ciechi viene promossa dall’impegno di Valentin Hauy che propose l’utilizzo delle lettere dell’alfabeto in rilievo e che nel 1784 fondò a Parigi il primo istituto dedicato all’educazione alla comunicazione e al lavoro dei ciechi, impegno che verrà ripreso da Luis Braille, che mise a punto un sistema di letto-scrittura con 63 combinazioni di segni (puntini in rilievo) che riproducono le lettere, i numeri e le note musicali.
La disabilità intellettiva e psichiatrica, che con la modernità era passata dal piano del trascendente a quello sociale, era comunque identificata con la povertà, l’incapacità di lavorare e la malattia e, di conseguenza, ritenuta un pericolo e risolta con l’internamento. È alla fine del XVIII secolo che assistiamo alle prime incrinature di queste certezze. Nel 1790 in Francia si cominciano a dividere i soggetti ritenuti riconducibili a un ordine sociale, e che quindi avrebbero potuto lasciare l’internamento, dagli incurabili, da cui la società doveva continuare a difendersi. Philippe Pinel, nominato responsabile dell’Istituto parigino di Bicetre, quale esperto delle “malattie dello spirito”, promosse la «liberazione dei folli dalle catene», non nel senso di una loro liberazione dall’internamento, ma, anche se istituzionalizzati, ritenuti degni di interesse medico ed educativo.
Sono i primi passi che con Jean Marct Gaspar Itard, chiamato da Pinel a occuparsi del “selvaggio dell’Aveyron”, fondarono l’ipotesi che le caratteristiche comportamentali potrebbero non essere un dato dei soggetti, ma il risultato della storia di abbandono, di isolamento e di pregiudizi che li ha caratterizzati.
Ma, conoscere la diversità secondo il metodo scientifico-sperimentale, oltre che a studiarla, significherà anche classificarla. Al museo anatomico di Napoli è possibile visitare una singolare collezione: teste di criminali giustiziati conservate nell’alcol, organi anatomici, feti deformi conservati in formalina. Per tutto il XIX secolo si svilupperà l’interesse per un collezionismo enciclopedico della diversità umana. Colore della pelle, struttura del cranio, conformazione dei volti diventarono riferimenti centrali degli studi. La misura dell’angolo facciale, proposto da Peter Camper, e il criterio del modello umano proposto dall’arte greca mutuato da Winckelmann, comporterà l’identificazione dell’aspetto fisico con le caratteristiche morali e fra l’aspetto estetico e le funzioni intellettuali. Sono teorie che verranno portate avanti in da Kaspar Lavater (Frammenti di fisiognomica) e da Joseph Gall. Sulla base di tali premesse, Francis Galton sosterrà che occorre selezionare coloro che impediscono il funzionamento fisico e mentale della razza e Cesare Lombroso, in Genio e follia, descrisse le caratteristiche tipiche della degenerazione: «[…] fronte convessa, sguardo sfuggente, naso all’insù e volto asimmetrico».
La legittimazione da parte della scienza di queste tesi consentirà ai nazisti di tradurre tali convinzioni nel programma di eutanasia, promosso dal ministro dell’interno Victor Brack con le seguenti parole:
«Vi prego – esordì- di avere la bontà di prendere in considerazione i documenti sanitari che state per esaminare. Non vi è alcuna speranza per questi abbozzi di vita. Non vi è nemmeno sofferenza. Voglio dire che siamo noi che soffriamo inutilmente per la loro sorte. E’ un lusso di cui possiamo fare a meno! […] Non sopprimeremo degli esseri umani, ma annienteremo un incubo».
Veicolato dall’orrore dei drammi vissuti, nel dopoguerra, si sviluppa un movimento critico che investirà, oltre alle istituzioni, anche la comunicazione. Il progressivo superamento dell’istituzionalizzazione, che sottraeva le persone disabili ai contesti di vita comuni a tutti, offrirà la possibilità di entrare in contatto con i temi della diversità umana da parte di un pubblico sempre più vasto. Uno sviluppo fino ad allora impensabile delle comunicazioni di massa e costituirà un fatto indubbiamente positivo, ma comporterà anche un rischio. La spettacolarizzazione del dolore, spinta dalla ricerca di ascolti, anestetizza, e finisce per nascondere più di quanto non riveli. I professionisti del dolore, enfatizzando, impediscono di capire la complessità delle persone e dei contesti delle loro vite, e, rendendo la storia delle persone emblematica, le sottraggono alla dimensione plurale e storica di ogni vita.
 Ci sono fortunatamente anche autori di una rappresentazione dell’umano che sa tenere insieme l’essere simili con l’essere diversi, aspetto inscindibile in ogni vita. La fotografa americana Diane Arbus (1923-1971) viene descritta come la “fotografa dell’emarginazione”. È questa un’etichetta che riduce la sua umanità e la sua professionalità a uno stereotipo. Mentre è l’approccio critico alle immagini che feriscono ciò che guida il suo lavoro. Ne è prova il fatto che tutti i suoi soggetti posano per lei, nessuno viene ripreso di sorpresa. La Arbus non ha inoltre mai fotografato un evento tragico, qualcosa che irrompe in una vita e la disorienta, né ha mai enfatizzato la sofferenza di chi ha una disabilità. Sa bene che un’immagine sottrae sempre il soggetto al suo contesto, che viene necessariamente tagliato, e che questo comporta la sottrazione della persona rappresentata dalla sua storia, forzandone l’identità in positivo o in negativo. Ne sono prova i lunghi titoli con cui correda le sue fotografie.
Ci sono fortunatamente anche autori di una rappresentazione dell’umano che sa tenere insieme l’essere simili con l’essere diversi, aspetto inscindibile in ogni vita. La fotografa americana Diane Arbus (1923-1971) viene descritta come la “fotografa dell’emarginazione”. È questa un’etichetta che riduce la sua umanità e la sua professionalità a uno stereotipo. Mentre è l’approccio critico alle immagini che feriscono ciò che guida il suo lavoro. Ne è prova il fatto che tutti i suoi soggetti posano per lei, nessuno viene ripreso di sorpresa. La Arbus non ha inoltre mai fotografato un evento tragico, qualcosa che irrompe in una vita e la disorienta, né ha mai enfatizzato la sofferenza di chi ha una disabilità. Sa bene che un’immagine sottrae sempre il soggetto al suo contesto, che viene necessariamente tagliato, e che questo comporta la sottrazione della persona rappresentata dalla sua storia, forzandone l’identità in positivo o in negativo. Ne sono prova i lunghi titoli con cui correda le sue fotografie.
«Rifiutando un’impostazione fondata sulla compassione, l’artista gioca sulla distanza e la posa; utilizzata finora per valorizzare il proprio oggetto, il suo significato è rovesciato dalla Arbus che contraddice, tramite la fissità, il sogno di benessere e di felicità veicolato, al contrario, da una fotografia posta al servizio della pubblicità».
(J. L. Daval, 1982)
Nel cinema, due sono i disegni per le sceneggiature che Federico Fellini dedica a personaggi disabili: lo “io matto” e il “mutilato”.
 Lo zio, ospite di un istituto psichiatrico, approfitta di una gita domenicale con la famiglia per salire su di un albero e gridare da lassù: «A’ voj una dona». È un grido che è una richiesta di riconoscimento che per lui, come per tanti disabili, non prevede la piena realizzazione di una vita adulta, che comprende ovviamente anche l’affettività e la sessualità.
Lo zio, ospite di un istituto psichiatrico, approfitta di una gita domenicale con la famiglia per salire su di un albero e gridare da lassù: «A’ voj una dona». È un grido che è una richiesta di riconoscimento che per lui, come per tanti disabili, non prevede la piena realizzazione di una vita adulta, che comprende ovviamente anche l’affettività e la sessualità.
Il mutilato, invece, non ha voce, è una persona ridotta a simbolo, che esiste socialmente solo per essere esibita e subito dopo dimenticata:
«Un giorno Starace doveva passare da Rimini. Alla stazione spuntò un treno imbandierato. C’era un gran sole. La banda esplose, squillarono le trombe, il treno entrava in stazione sbuffando un gran fumo bianco: Che apparizione! Poi, diradatosi il fumo, restò Starace, un ometto, con un gran nasone, che disse: “camerati riminesi”. La gente impazzì, forse perché l’ometto aveva detto “riminesi”; squillarono di nuovo le trombe: credo che Starace non abbia detto altro. Quindi gli fu presentato un mutilato che la gente portava in braccio dopo averlo tolto dalla carrozzina. In quelle occasioni venivano portati avanti, diventando improvvisamente importanti, ciechi, storpi, zoppi: quanti ne vedemmo allora sui balconi, sulle piazze, nei teatri».
(F. Fellini, 1967)