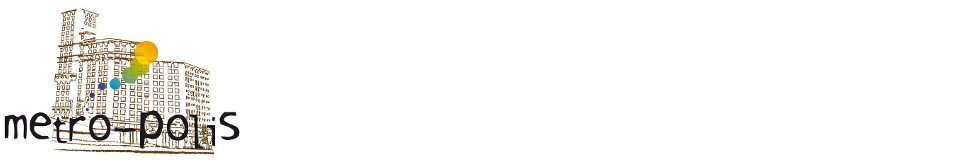di Roberta Merighi
 «Noi non sapevamo che cosa stava per succedere. Nessuno ci diceva nulla. Mio padre continuava ad essere ottimista e continuava a credere che i soldati olandesi avrebbero protetto i civili, senza badare al fatto che egli stesso vedeva i Cetnici [così erano chiamati i nazionalisti serbi] all’interno della fabbrica [la base dei caschi blu]. […] Gli olandesi non avevano armi […] e notai che non sembravano più così sicuri come al nostro arrivo alla base. Ciò che veramente mi sorprese fu che essi stessi stavano presso quei sacchi di plastica dove gli uomini erano costretti a svuotare le loro tasche. Siccome camminavo dietro a mio padre Lutvo, vidi quando un soldato olandese lo forzò a lasciare nei sacchi persino il suo berretto. Io pensavo ai soldati olandesi che ci avevano promesso che nulla di brutto ci sarebbe successo, che ci avevano detto di non aver paura perché ci avrebbero protetto. Quando fummo molto vicini ad uno degli autobus parcheggiati, uno dei Cetnici che indossava una uniforme olandese si avvicinò e disse a mio padre: “Tu vecchio seguimi”. Io mi girai e vidi un folto gruppo di uomini che erano già stati separati dagli altri. Mio padre Lutvo fu costretto a raggiungerli. A causa degli olandesi il sogno di mio padre di raggiungere un territorio libero non si avverò».
«Noi non sapevamo che cosa stava per succedere. Nessuno ci diceva nulla. Mio padre continuava ad essere ottimista e continuava a credere che i soldati olandesi avrebbero protetto i civili, senza badare al fatto che egli stesso vedeva i Cetnici [così erano chiamati i nazionalisti serbi] all’interno della fabbrica [la base dei caschi blu]. […] Gli olandesi non avevano armi […] e notai che non sembravano più così sicuri come al nostro arrivo alla base. Ciò che veramente mi sorprese fu che essi stessi stavano presso quei sacchi di plastica dove gli uomini erano costretti a svuotare le loro tasche. Siccome camminavo dietro a mio padre Lutvo, vidi quando un soldato olandese lo forzò a lasciare nei sacchi persino il suo berretto. Io pensavo ai soldati olandesi che ci avevano promesso che nulla di brutto ci sarebbe successo, che ci avevano detto di non aver paura perché ci avrebbero protetto. Quando fummo molto vicini ad uno degli autobus parcheggiati, uno dei Cetnici che indossava una uniforme olandese si avvicinò e disse a mio padre: “Tu vecchio seguimi”. Io mi girai e vidi un folto gruppo di uomini che erano già stati separati dagli altri. Mio padre Lutvo fu costretto a raggiungerli. A causa degli olandesi il sogno di mio padre di raggiungere un territorio libero non si avverò».
 «Sapevamo che i Cetnici sarebbero entrati nella base, ma non c’era altro posto dove andare. Solo speravamo che i soldati olandesi non avrebbero permesso di farci alcunché. Poi i Cetnici arrivarono. Alcuni di essi indossavano uniformi olandesi. Andavano chiedendo dove fossero andati gli altri uomini. Poi presero il mio vicino Habib e lo portarono in una stanza per interrogarlo. Io sentivo le sue urla. Nessuno osava andare a vedere cosa stesse succedendo. Improvvisamente la porta si aprì e Habib ricomparve. Era molto pallido. Passandomi accanto mi disse: “È la nostra fine. Uccideranno tutti gli uomini”».
«Sapevamo che i Cetnici sarebbero entrati nella base, ma non c’era altro posto dove andare. Solo speravamo che i soldati olandesi non avrebbero permesso di farci alcunché. Poi i Cetnici arrivarono. Alcuni di essi indossavano uniformi olandesi. Andavano chiedendo dove fossero andati gli altri uomini. Poi presero il mio vicino Habib e lo portarono in una stanza per interrogarlo. Io sentivo le sue urla. Nessuno osava andare a vedere cosa stesse succedendo. Improvvisamente la porta si aprì e Habib ricomparve. Era molto pallido. Passandomi accanto mi disse: “È la nostra fine. Uccideranno tutti gli uomini”».
 «Intorno all’una arrivò il nostro turno di evacuare la base. Notai alcuni nastri adesivi dall’altro lato della strada lungo i quali dovevamo passare per raggiungere gli autobus. Ero con la mia famiglia, dietro seguivano mio padre Salko e mio zio Saban. Raggiunta la fine dei nastri un soldato cetnico si rivolse a mio padre e mio zio: “Voi due, venite da questa parte”. Mi fermai e vidi mio padre e mio zio andare verso un gruppo di uomini che erano separati da tutti gli altri. Mi rivolsi ad un soldato olandese e cercai di spiegargli che mio padre era un uomo anziano. Lo pregai di aiutarmi. Egli mi indicò solamente gli autobus facendomi capire che essi sarebbero arrivati a Tuzla dopo di me. […] Vidi anche quando essi dissero ad un uomo anziano di Ceska di raggiungere gli uomini che erano separati dagli altri. La sua nipotina di 5 anni era con lui e si teneva saldamente stretta alla sua mano. La piccola viveva con lui da quando i suoi genitori erano rimasti uccisi a Ceska. Molto probabilmente egli non aveva nessuno a cui affidarla e che se ne prendesse cura, né qualcuno che la potesse portare con sé a Tuzla, così decise di non lasciarla. Tenendosela stretta per mano, egli raggiunse il gruppo di uomini. I Cetnici non ci fecero neppure caso».
«Intorno all’una arrivò il nostro turno di evacuare la base. Notai alcuni nastri adesivi dall’altro lato della strada lungo i quali dovevamo passare per raggiungere gli autobus. Ero con la mia famiglia, dietro seguivano mio padre Salko e mio zio Saban. Raggiunta la fine dei nastri un soldato cetnico si rivolse a mio padre e mio zio: “Voi due, venite da questa parte”. Mi fermai e vidi mio padre e mio zio andare verso un gruppo di uomini che erano separati da tutti gli altri. Mi rivolsi ad un soldato olandese e cercai di spiegargli che mio padre era un uomo anziano. Lo pregai di aiutarmi. Egli mi indicò solamente gli autobus facendomi capire che essi sarebbero arrivati a Tuzla dopo di me. […] Vidi anche quando essi dissero ad un uomo anziano di Ceska di raggiungere gli uomini che erano separati dagli altri. La sua nipotina di 5 anni era con lui e si teneva saldamente stretta alla sua mano. La piccola viveva con lui da quando i suoi genitori erano rimasti uccisi a Ceska. Molto probabilmente egli non aveva nessuno a cui affidarla e che se ne prendesse cura, né qualcuno che la potesse portare con sé a Tuzla, così decise di non lasciarla. Tenendosela stretta per mano, egli raggiunse il gruppo di uomini. I Cetnici non ci fecero neppure caso».
 «Avvicinandomi ad uno degli autobus vidi ancora diversi soldati con l’uniforme olandese che stavano separando gli uomini dalle donne e dai bambini. Agli uomini era ordinato di mettersi da un lato mentre alle donne era permesso di salire sui veicoli. Quando fummo vicini ad un autobus uno di quei soldati […] ordinò a mio marito di unirsi ad un folto gruppo di uomini. Io salii sull’autobus con i miei bambini e subito l’autobus partì alla volta di Bratunac. Un autobus pieno di uomini ci seguiva. Mio marito era in quell’autobus. Arrivati a Kravica il nostro autobus continuò oltre, mentre l’autobus che trasportava gli uomini rimase a Kravica».
«Avvicinandomi ad uno degli autobus vidi ancora diversi soldati con l’uniforme olandese che stavano separando gli uomini dalle donne e dai bambini. Agli uomini era ordinato di mettersi da un lato mentre alle donne era permesso di salire sui veicoli. Quando fummo vicini ad un autobus uno di quei soldati […] ordinò a mio marito di unirsi ad un folto gruppo di uomini. Io salii sull’autobus con i miei bambini e subito l’autobus partì alla volta di Bratunac. Un autobus pieno di uomini ci seguiva. Mio marito era in quell’autobus. Arrivati a Kravica il nostro autobus continuò oltre, mentre l’autobus che trasportava gli uomini rimase a Kravica».
 «Il 13 luglio un soldato olandese ci disse che saremmo stati evacuati […]. Perciò mio marito credeva che il battaglione olandese avrebbe salvato tutti gli uomini […] Non ho pensato in alcun momento che qualcuno avrebbe potuto essere in pericolo poiché, come dissi, non sapevamo nulla di quello che stava succedendo fuori dalla base. Mio marito non esitò un attimo a lasciare la base, ma coloro che si avviavano piano o esitavano erano spinti fuori dai soldati olandesi che si trovavano nei pressi. […] Quando oltrepassai il cancello mio marito ed io per la prima volta vedemmo che gli uomini venivano separati dalle donne e dai bambini. Anche se lo sapevano, i soldati olandesi non ci avevano detto niente. Alcuni uomini furono presi dal panico e tentarono di rientrare alla base, ma furono spinti fuori dagli olandesi […]. Mio marito non ebbe alcuna scelta se non quella di raggiungere gli altri raggruppati in un fossato».
«Il 13 luglio un soldato olandese ci disse che saremmo stati evacuati […]. Perciò mio marito credeva che il battaglione olandese avrebbe salvato tutti gli uomini […] Non ho pensato in alcun momento che qualcuno avrebbe potuto essere in pericolo poiché, come dissi, non sapevamo nulla di quello che stava succedendo fuori dalla base. Mio marito non esitò un attimo a lasciare la base, ma coloro che si avviavano piano o esitavano erano spinti fuori dai soldati olandesi che si trovavano nei pressi. […] Quando oltrepassai il cancello mio marito ed io per la prima volta vedemmo che gli uomini venivano separati dalle donne e dai bambini. Anche se lo sapevano, i soldati olandesi non ci avevano detto niente. Alcuni uomini furono presi dal panico e tentarono di rientrare alla base, ma furono spinti fuori dagli olandesi […]. Mio marito non ebbe alcuna scelta se non quella di raggiungere gli altri raggruppati in un fossato».
 «Quando fummo vicini ad uno dei veicoli, uno dei Cetnici si avvicinò e disse a mio figlio: “Dai il tuo zaino a questa donna e seguimi”. Io mi girai e cercai di spiegargli che mio figlio aveva solo 16 anni, ma non mi stava ad ascoltare. Prese mio figlio per una mano. Io afferrai mio figlio Senad per l’altra e cercai di divincolarlo dalla presa del Cetnico. Ad alcuni metri da noi c’erano 4/5 soldati olandesi che ci guardavano senza intervenire a proteggerci. Dato che il Cetnico era più forte di me, alla fine dovetti lasciare la mano di mio figlio. Il Cetnico lo prese e gli ordinò di salire su di un autobus pieno di uomini. Io cominciai a piangere e andai dagli olandesi cercando di spiegare loro l’accaduto anche se essi lo avevano visto benissimo. Uno di loro mi toccò una spalla e disse: “Non disperarti madre, tuo figlio arriverà a Tuzla dopo di te”. Io sapevo che erano vuote promesse, tuttavia sperai che avrei rivisto ancora mio figlio».
«Quando fummo vicini ad uno dei veicoli, uno dei Cetnici si avvicinò e disse a mio figlio: “Dai il tuo zaino a questa donna e seguimi”. Io mi girai e cercai di spiegargli che mio figlio aveva solo 16 anni, ma non mi stava ad ascoltare. Prese mio figlio per una mano. Io afferrai mio figlio Senad per l’altra e cercai di divincolarlo dalla presa del Cetnico. Ad alcuni metri da noi c’erano 4/5 soldati olandesi che ci guardavano senza intervenire a proteggerci. Dato che il Cetnico era più forte di me, alla fine dovetti lasciare la mano di mio figlio. Il Cetnico lo prese e gli ordinò di salire su di un autobus pieno di uomini. Io cominciai a piangere e andai dagli olandesi cercando di spiegare loro l’accaduto anche se essi lo avevano visto benissimo. Uno di loro mi toccò una spalla e disse: “Non disperarti madre, tuo figlio arriverà a Tuzla dopo di te”. Io sapevo che erano vuote promesse, tuttavia sperai che avrei rivisto ancora mio figlio».
 Questi sono spezzoni di alcune delle tante testimonianze rese dalle madri, dalle mogli e dalle figlie sopravvissute ai terribili giorni dell’eccidio dei musulmani bosniaci, di tutti i maschi dai 12 ai 77 anni, ma anche di molte donne, stuprate prima di essere massacrate. Eccidio compiuto nell’enclave di Srebrenica dall’esercito serbo-bosniaco e da gruppi paramilitari serbi. Sono racchiuse nel libro The United Nations on the Sebrenica’s pillar of shame, raccolte dall’associazione “Donne di Srebrenica”.
Questi sono spezzoni di alcune delle tante testimonianze rese dalle madri, dalle mogli e dalle figlie sopravvissute ai terribili giorni dell’eccidio dei musulmani bosniaci, di tutti i maschi dai 12 ai 77 anni, ma anche di molte donne, stuprate prima di essere massacrate. Eccidio compiuto nell’enclave di Srebrenica dall’esercito serbo-bosniaco e da gruppi paramilitari serbi. Sono racchiuse nel libro The United Nations on the Sebrenica’s pillar of shame, raccolte dall’associazione “Donne di Srebrenica”.
Un atto d’accusa nei confronti degli autori materiali dell’eccidio – l’esercito serbo-bosniaco capitanato dal Generale Ratko Mladic e gruppi ultranazionalisti serbi -, ma anche di tutte quelle forze – NATO, ONU – che avrebbero dovuto proteggerla e non lo fecero.
Il libro ci venne dato durante la visita nella loro sede, completamente tappezzata delle foto dei loro cari, dalle superstiti dagli occhi ormai asciutti dopo le troppe lacrime, persi nell’indicibile dolore. Ci dissero che si sentivano morte dentro. Mentre la psichiatra ci spiegava gli interventi di aiuto e supporto ai tanti orfani da riaccompagnare alla vita.
 Srebrenica e la sua enclave erano state dichiarate “zona di sicurezza” dalla risoluzione 819 delle Nazioni Unite, votata il 16 aprile del 1993 perché, a stragrande maggioranza musulmana, ma prossima ad un’area a maggioranza serba, era oggetto di continui attacchi da parte dell’esercito serbo-bosniaco e di quei gruppi para-militari che intendevano includerla nel loro progetto di Grande Serbia.
Srebrenica e la sua enclave erano state dichiarate “zona di sicurezza” dalla risoluzione 819 delle Nazioni Unite, votata il 16 aprile del 1993 perché, a stragrande maggioranza musulmana, ma prossima ad un’area a maggioranza serba, era oggetto di continui attacchi da parte dell’esercito serbo-bosniaco e di quei gruppi para-militari che intendevano includerla nel loro progetto di Grande Serbia.
Il 10 luglio, all’approssimarsi dell’arrivo dei serbo-bosniaci, il giovane giornalista della radio locale, anch’egli inghiottito, poi, nel genocidio, pronuncia le sue ultime parole alla radio: “Quello che sta succedendo a Srebrenica è impossibile da descrivere. C’è qualcuno nel mondo che viene a vedere la tragedia che sta accadendo a Srebrenica e ai suoi abitanti? La popolazione di questa città sta scomparendo. C’è Akashi [inviato dell’ONU] dietro a tutto questo o Bouthros Ghali [presidente dell’ONU] o qualcun altro? Ho paura che non sarà più importante [saperlo] per Srebrenica”.
 L’11 luglio la popolazione della città e delle aree limitrofe, all’entrata dell’esercito serbo-bosniaco, realizzando dolorosamente che il promesso intervento della Nato per fermare l’avanzata dei “cetnici” non ci sarebbe stato, che non avevano alcuna possibilità di difesa avendo consegnato le loro armi all’ONU, si riversò in massa nella vicina Potocari alla dismessa fabbrica che fungeva da base per i caschi blu olandesi, in cerca di protezione. Molti cercarono di raggiungere Tuzla attraverso boschi e campi minati, in quella che è stata definita “la marcia della morte”.
L’11 luglio la popolazione della città e delle aree limitrofe, all’entrata dell’esercito serbo-bosniaco, realizzando dolorosamente che il promesso intervento della Nato per fermare l’avanzata dei “cetnici” non ci sarebbe stato, che non avevano alcuna possibilità di difesa avendo consegnato le loro armi all’ONU, si riversò in massa nella vicina Potocari alla dismessa fabbrica che fungeva da base per i caschi blu olandesi, in cerca di protezione. Molti cercarono di raggiungere Tuzla attraverso boschi e campi minati, in quella che è stata definita “la marcia della morte”.
Occupata la città, Mladic si recò a Potocari. I filmati che avrebbero dovuto celebrare la sua vittoria, sono una prova e un atto d’accusa di ciò che avvenne anche se la verità stentò ad essere resa pubblica. Lo fu soprattutto per la caparbia e disperata volontà di chi sopravvisse a quell’orrore.
 Tutto è documentato: l’arrivo di un Mladic trionfante che si permette di rassicurare la popolazione raccolta dentro, ma soprattutto tenuta fuori dal compound, persino di far distribuire caramelle ai bambini, l’incontro con l’attonito comandante del Dutchbatt III olandese, Karremans, che accetta qualunque decisione dei comandanti serbo-bosniaci, senza approntare nessun tipo di difesa di quella popolazione che gli chiedeva quello che era nei suoi compiti: protezione. I brindisi fra Mladic, Kristic, il suo braccio destro, e Karremans prima e dopo la mattanza sono raccapriccianti. Nell’ultimo brindisi Karremans è più disteso, sa che può partire, lasciare quei posti. Accetta per sé e per la moglie i doni che Mladic gli porge e ringrazia. Appena arrivato in Croazia parlerà di «un’operazione militare eccellentemente pianificata».
Tutto è documentato: l’arrivo di un Mladic trionfante che si permette di rassicurare la popolazione raccolta dentro, ma soprattutto tenuta fuori dal compound, persino di far distribuire caramelle ai bambini, l’incontro con l’attonito comandante del Dutchbatt III olandese, Karremans, che accetta qualunque decisione dei comandanti serbo-bosniaci, senza approntare nessun tipo di difesa di quella popolazione che gli chiedeva quello che era nei suoi compiti: protezione. I brindisi fra Mladic, Kristic, il suo braccio destro, e Karremans prima e dopo la mattanza sono raccapriccianti. Nell’ultimo brindisi Karremans è più disteso, sa che può partire, lasciare quei posti. Accetta per sé e per la moglie i doni che Mladic gli porge e ringrazia. Appena arrivato in Croazia parlerà di «un’operazione militare eccellentemente pianificata».
L’evacuazione del campo avviene come le testimonianze su riportate bene ci descrivono e dura diversi giorni. Ma già subito fuori dalla base incomincia l’eccidio nella tristemente famosa “casa bianca” che dal compound non è lontana.
I soldati olandesi si lasciano disarmare: con le loro armi, uniformi e automezzi i serbo-bosniaci, travestiti da peacekeeper, riescono a ingannare molti dei fuggiaschi che, catturati, vengono uccisi sul ciglio della strada.
Ma i caschi blu olandesi erano già arrivati nel paese disarmati culturalmente e psicologicamente incapaci di comprendere la realtà complessa in cui si trovavano e affetti da una sorta di superiorità etnica che fa riempire il compound di scritte sprezzanti nei confronti della popolazione musulmana e offensive nei confronti delle ragazze bosniache. Queste scritte sono tuttora leggibili sui muri della loro ex base trasformata in Mausoleo. E dove si possono vedere tutti i filmati relativi a quelle giornate, inclusi quelli che documentano le esecuzioni dei giovani ingannati e uccisi, l’uno dopo l’altro, sul bordo della strada.
Il genocidio pianificato dei musulmani dura per giorni. I cadaveri vengono gettati in fosse comuni. Solo quando gli organismi internazionali denunciano il sospetto della sparizione da Srebrenica di circa 7000 uomini (ma in realtà più di 10.700), allora si compie un altro scempio. I cadaveri, già spogliati della loro identità, vengono riesumati dai loro carnefici e, fatti a pezzi, traslocati e sparsi in diverse fosse comuni.
Da allora la ricerca dei corpi è l’arduo compito di medici e di antropologi. È un compito reso sempre più difficile, una corsa contro il tempo per ricomporre corpi smembrati e deteriorati, per dar loro un nome e infine una sepoltura. Questa ricerca dura da anni. Nel corso di ogni anno si cercano le fosse comuni, si disseppelliscono e si ricompongono quei corpi. E quando quei corpi vengono ricomposti “per almeno il 70 per cento” si cerca, attraverso l’esame del DNA o di brandelli di vestiti o di qualche oggetto personale sfuggito ai carnefici, di dare loro anche un’identità. Per dare, infine, una sepoltura.
E questo avviene ogni 11 luglio con cerimonia pubblica nel mausoleo dedicato.
Le donne di Srebrenica, organizzate in associazione, hanno combattuto a lungo perché emergesse la verità e fossero perseguiti i responsabili, tutti i responsabili anche quelli della comunità internazionale. Le testimonianze rese dai superstiti sono state inviate al Tribunale Penale Internazionale (TPI). Questi però ha rigettato l’ultima richiesta, quella di mettere sotto accusa anche la comunità internazionale. D’altra parte «il fatto è che questa associazione non era ottimista che ci sarebbe stata una messa sotto accusa, sapendo che il tribunale è stato fondato dall’UN», dicono nella prefazione al libro che abbiamo citato.
Tuttavia il TPI nel 2001, nel processo contro Radislav Kristic, ha decretato che quella di Srebrenica è stata «una delle peggiori atrocità dopo quelle della seconda guerra mondiale» e nel 2004 che «un genocidio si è consumato a Srebrenica contro i musulmani di Bosnia».
Dopo lunga latitanza nel 2011 anche Ratko Mladic è stato catturato e nel 2017 condannato all’ergastolo per tutte le imprese criminali compiute durante la guerra in Bosnia e specificatamente per il genocidio dei musulmani di Srebrenica.
Ogni volta che nel Giorno della Memoria diciamo “mai più” ricordiamoci che un genocidio è avvenuto di nuovo. Nella “civile” Europa. Sotto gli occhi della comunità internazionale. Sotto i nostri occhi.
Ricordiamo Srebrenica.