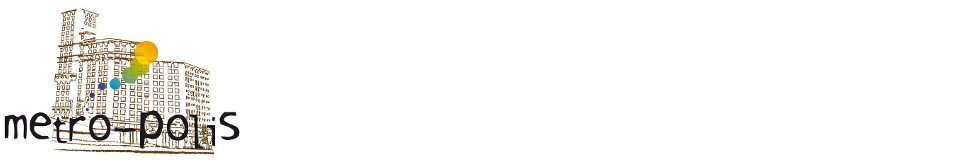di Serena Di Ruscio

Sono emigrata in Francia il 28 agosto 2011. Non lo sapevo al tempo, pensavo che sarei andata a vedere cosa c’era fuori dall’Italia.
Non so bene come mai, ma fino al secondo anno non credevo di avere cambiato casa. Ero in Italia, in quella che considero ancora casa mia, era Natale. Mi infilavo le scarpe per andare in aeroporto e tornare in Francia, quella che non pensavo ancora come casa. Non abitavo più lì, ci ho messo due anni ad accorgermene.
La mia incoscienza nel 2011 mi sorprende a oggi.
Il secondo giorno in Francia mi sono accorta che la straniera ero io. Nei mesi precedenti non ci avevo mai pensato. Me ne sono accorta perché la mia lingua era stentata, la gente mi guardava interrogativamente quando parlavo (ancora oggi, a volte), in questi casi vi è imbarazzo e isolamento, il desiderio di essere capiti. Col tempo mi sono accorta che il mio sentimento di estraneità non era dettato unicamente da una differenza linguistica ma anche culturale. Ho studiato un po’ di sociologia al liceo, ma non mi è mai venuto in mente che la Francia potesse avere una cultura diversa, prima del 2011. Non ci avevo mai pensato, che fosse anche perchè avevo 21 anni? È vicina, è Europa.
La mancanza di una storia culturale condivisa ti rende nuovamente diverso, le persone con cui hai contatto quotidianamente non hanno studiato la Divina Commedia a scuola, non hanno visto gli stessi cartoni da piccoli, non hanno idea della politica del tuo paese e come questa influisca sulla vita quotidiana, non sono cresciuti in piccole vie medievali, non sanno come sia strutturato il sistema scolastico da te, non pensano come te, sembra.
Si dice che al cambiamento di lingua si cambi personalità, sono cinque anni che condivido la mia vita con un portoghese.
Prima le mie relazioni stabili, sono state unicamente con italiani. Entrambi sapevamo il francese e l’inglese, la comunicazione era possibile. La facilità di pensiero e la spontaneità caratteriale, proprie della mia lingua madre, erano necessarie all’intimità relazionale che volevo instaurare col mio compagno. Così ho cominciato a parlargli in italiano, Jorge parla italiano, ora.
E io portoghese.
In fondo erano 22 anni che parlavo (unicamente) in italiano, che ho pensato, consumato, mangiato, scritto, ascoltato, letto e bevuto italiano.
Poter condividere la lingua che mi ha formata.
Forse per me era importante che mi conoscesse anche da questo punto di vista.
Ci sono studi che parlano di come le comunità di portoghesi in Francia non volessero parlare in portoghese (la loro lingua intima) con persone al dì fuori del loro cerchio.
In francese, ci sono espressioni come «il s’est fait larguer»1, oppure «il s’est fait aggresser». Spesso la causa degli eventi negativi viene attribuita a chi nell’azione è passivo. L’espressione è solo tale, viene usata da sempre, tutti i francesi con cui ne ho parlato non avevano mai riflettuto su ciò. Io da straniera, fruitrice di una lingua relativamente nuova per me, quando sento «si è fatto aggredire» mi sento a disagio.
Sembra che la prospettiva di chi parla definisca il mondo circostante. Ma non è sempre così?
Non sono abituata all’espressione, al modo di pensare, al pensiero francese. Perché non sono francese.
Il 28 agosto del 2018 ho compiuto sette anni in Francia, che sono straniera.
Nessuno dei miei amici, qui, immigrati, si scorda la data di arrivo, c’è chi la festeggia. Scrivo perché sono sorpresa di come dopo sette anni di convivenza con questo paese, che ritengo sotto certi aspetti il mio, io mi senta ancora straniera.
Comincio a pensare che sia un sentimento che non se ne andrà mai.
 La gente lo sa quando comincio a parlare, non mi sono mai sforzata troppo di nascondere il mio accento (che definisco con orgoglio di resistenza). Lo sa quando racconto di cose alle quali non avevano mai pensato, non essendo stranieri. Lo sa quando chiedo per l’ennesima volta cosa significa CP1.2 Lo sa quando mi esprimo in maniera bizzarra. Lo sa quando non conosco una regione o un piatto tradizionale.
La gente lo sa quando comincio a parlare, non mi sono mai sforzata troppo di nascondere il mio accento (che definisco con orgoglio di resistenza). Lo sa quando racconto di cose alle quali non avevano mai pensato, non essendo stranieri. Lo sa quando chiedo per l’ennesima volta cosa significa CP1.2 Lo sa quando mi esprimo in maniera bizzarra. Lo sa quando non conosco una regione o un piatto tradizionale.
Lo sa quando mi presento, tout simplement. Il mio nome incomprensibile, che sono costretta a ripetere tre volte, spesso distorcendolo in una maniera e con un accento ai quali, prima di essere straniera, non ero abituata. səʁe’na non c’era prima del 2011.
Lo senti sulla pelle tutti i giorni, il tuo essere minorità, vulnerabile quando fai un colloquio di lavoro, quando racconti della tua terra a dei francesi che non sono mai usciti dal loro paese, quando ti chiedono da dove viene il tuo piccolo accento (anche se sai che è enorme ma i francesi per essere “simpatici” lo chiamano piccolo) – alla meglio, perché al peggio ti chiedono com’è che non ti si è naturalizzato l’accento -, quando cammini per strada e sai di essere diverso, anche se da fuori potresti passare per uno di loro.
Perché io non mi copro la testa col fazzoletto, come facevano le mie nonne, perché la mia pelle è chiara (anche troppo chiara per essere italiana come mi disse un francese) e i miei tratti occidentali, perché non sembri estranea, eppure, lo senti. Lo senti quando ti riconosci più simile agli africani, indios, sudamericani, o asiatici di quanto tu non possa sentirti rispetto a chi fa parte della cultura dominante. Perché la tua condizione si avvicina di più, perché anche tu come loro, non sei francese.
Mi chiedo se anche mio padre, con la sua emigrazione interna si sia sentito così, o se è solo la Francia a essere spietata. Mi chiedo se anche mio nonno di cui porto il nome, che non ho mai conosciuto, si sia sentito così.
Oltre al nome, mi sono rimaste le ricette, del mio avo siculo, che come diceva Oriol mi permettono di incorporare quella tradizione identitaria, di mangiare la mia origine e attuare una riappropriazione di resistenza, su un territorio che non mi è casa3. O è?
Mi dico che dopo sette anni dovrei sentirmi almeno un po’ francese, o che questo mio bisogno di definirmi, sentirmi straniera si attenui col tempo. Ma pare di no.
Una delle prime cose che mi fecero specie in questo posto straniero è il fatto che i parigini non considerano la periferia Parigi. Non so se questo è valido anche per Roma, ma ieri parlavo con una brasiliana e mi diceva che chi viene dalla periferia di San Paolo dice di venire da San Paolo.
I parigini tengono a essere parigini, a separarsi da chi abita in periferia. I periferici, o meglio banlieusards, tengono a separarsi (per risposta coerente) dai parigini. I parigini hanno la nomea di stronzi, loro stessi lo sanno e al banlieusard l’associazione non piace. Ma sono convinta che se cercassimo l’origine della dissociazione non vi troveremmo, per primo, l’azione del più povero, non dominante, periferico.
I francesi sono stati cresciuti in edifici che predicano la repubblica come se si parlasse di un monarca. I valori repubblicani come leggi razziali, l’importanza della nazione, la grandeur del loro popolo come un dato acquisito. Sulla facciata di ogni scuola vi è il ricordo di quello che loro sembrano considerare il più grande successo del loro popolo: liberté. égalité, fraternité.
Sono loro ad aver stilato la prima carta dei diritti umani, ad aver portato i valori della repubblica in tutte quelle colonie che a oggi considerano territorio francese (anche se è a 12 ore di aereo).
Ogni discorso politico si conclude con Vive la France, Vive la Republique, indipendentemente dal partito politico di appartenenza del Presidente. La fierezza francese, la consapevolezza di essere migliori è instillata culturalmente, forse per questo si dice che i francesi sono arroganti.
Altro fatto sorprendente è come esistano due tipi di francesi (questa definizione viene usata anche in politica e in televisione): i francesi, prima categoria, e i francesi di origine. Se io decido di fare dei figli in Francia, non saranno mai francesi. Saranno francesi di origine. Non hai ascendenze francesi? (statisticamente un francese su tre, ovvero il 33% della popolazione4). Non sei francese, o meglio, sei francese ma di origine (straniera).
Com’è possibile che il salto generazionale, la nascita sul territorio (francese), spesso il non apprendimento della lingua di origine, non ti diano, ancora, il diritto di essere come loro?
Dopo sette anni non mi sento a casa, o meglio, non come in Italia. Dopo sette anni non credo che mi sentirò mai più a casa di quanto io già non mi possa sentire ora. Ho fatto l’università qui, pagato la mia prima bolletta in Francia, intestata a mio nome, lavorato in diverse città, imparato a cucinare qui. La mia prima casa, sola, è stata qui.
Sono cresciuta in Italia, ma sono diventata adulta in Francia.
Certe stazioni metro mi ricordano cose che sono successe anni fa. Perché Parigi è la mia città, in qualche modo, lo è diventata. Come Bologna.
Eppure il sentimento di doppia assenza che descrive Sayad, sociologo algerino, non se ne andrà mai. In Francia sarò sempre italiana, in Italia sarò sempre quella che è partita.
Quella che sono sette anni che è andata via. Sono a metà.
Ci sono dei luoghi dove essere immigrato non comporta essere straniero? Dove non ci si ricorda quotidianamente del gap? È una questione di immigrazione francese? Questa incapacità di assimilazione è alla base della radicalizzazione, dell’isolamento sentito anche nella seconda generazione di migranti? Il razzismo istituzionale è una scelta politica cosciente? O si tratta di un retaggio culturale di strascico?
Mi sarebbe piaciuto che Sayad avesse parlato di una doppia presenza, ma forse il sentimento di mal du pays, di saudade, è più forte tra gli immigrati, rispetto a quello di appartenenza in due luoghi.
Sono contenta di sapere che come Maya ho la possibilità di cercare di liberarmi ogni giorno:
Ogni giorno trovare il più giusto per me, appartenere a me stessa e poter navigare ogni luogo, senza necessariamente sentirmi privata, o battermi per la mia accettazione.
Note
1 Gergo che sta per “lasciarsi”.
2 Divisione in classi nella scuola primaria, un po’ come in italiano diremmo la 1a.
3 «(…) nous interpénétrons dans le même sens, l’exemple relevé par Rosita Fibbi, des italiens de Genève qui ont fait venir, dans une phase très précoce de l’immigration, des produits alimentaire de “chez eux”, parce qu’ils les jugeaient plus “réconfortants”. (…) une illustration de la thèse de Bordieu selon que la marque distinctive de l’aliment populaire c’est “qu’il tient au corps” (Bordieu, 1979). C’est aussi que le corps, objectivé par le regard du dominant et la discipline qu’il impose ne peut être réapproprié que sur le terrain même d’un objectivation collectivement contrôlée. Des nourritures symboliquement marquées permets, littéralement, “d’incorporé” la tradition partagée qui rassure ainsi chaque sujet menacée d’être dépouillée de sa propre intimité». (Oriol 1985)
4 Solo sull’hexagone, sul territorio francese, ne sono escluse quindi la Corsica, le ex-colonie.