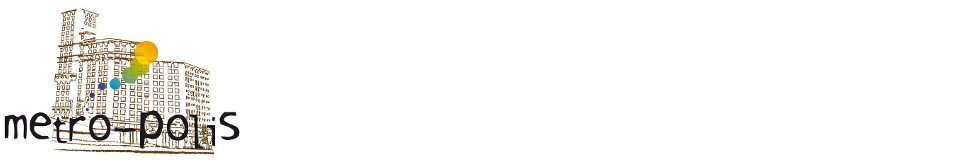Al-Khalil, Hebron in ebraico, è l’apice della contraddizione, tra contrapposizione e mescolamento, tra esclusione e scontro. Il significato etimologico del nome di questa città, situata a 30 chilometri a sud di Gerusalemme, è “Amico”, in arabo come in ebraico. Un luogo straziato da odi viscerali ma che, ossimoro vivente, richiama ad una fratellanza che non c’è. Al-Khalil è un tappeto che ricopre i colli tipici del sud della Cisgiordania, è un saliscendi continuo, una città ondulata, una città ardua. Qui vivono più di 200000 Palestinesi e tra i 500 e gli 800 coloni israeliani, “protetti” da almeno 2000 soldati delle forze di occupazione. Qui l’esperimento dello Stato sionista di esclusione degli indesiderati ha raggiunto il livello più alto di perfezionamento, è aperto, palese, eloquente.
Il 25 Febbraio 1994, Baruch Goldstein, colono di origine statunitense, aprì il fuoco all’interno della Moschea di Ibrahim e uccise 29 Palestinesi in preghiera, ferendone 125. Fu sepolto nella a Kiryat Arba, colonia illegale che è una lama di coltello che lambisce la città e vi penetra dentro; sulla sua tomba c’è scritto “Al santo Baruch Goldstein, che diede la sua vita per il popolo ebraico, la Torah e la nazione di Israele”.
Da allora, la città fu divisa in due zone: H1, sotto il controllo palestinese, e H2, sotto il controllo israeliano. Quest’ultima sezione, che comprende il centro storico della città, è abitata da decine di migliaia di palestinesi, che anno dopo anno si vedono costretti ad abbandonare la loro abitazione. Parlare di restrizioni è un eufemismo: solo per fare qualche esempio, essi subiscono ogni il divieto di transito in automobile, i checkpoint per entrare e uscire dall’area come anche quelli all’interno, la chiusura di centinaia di negozi, strade sbarrate da muri e filo spinato. La sensazione immediata che ho è di passeggiare per una città fantasma, svuotata ed esangue, il cui confine non è stato tracciato ma innalzato, barriere di cemento armato che soffocano le arterie di un corpo agonizzante.
Shuhada Street, la strada dei martiri, è l’emblema di questa follia. I negozi che si affacciano su questa via sono sbarrati, e sui loro portoni sono evidenti le stelle di David disegnate con la bomboletta dai coloni; su uno, in particolare, si legge chiaramente “Gas the Arabs”. È un déjà vu che gela il sangue.
Nel bel suq che si articola per le stradine poco distanti c’è un non so che di inquietante: alzo lo sguardo e vedo una grata sopra alla mia testa, a tre metri di altezza, piena di spazzatura. I coloni hanno occupato i piani superiori degli edifici e gettano sui passanti ogni sorta di oggetti, sassi, spazzoloni per il gabinetto, rifiuti di tutti i tipi, feci. Vedo anche un paio di bottiglie di vino. Tra le architetture arabeggianti spunta improvvisa una torretta militare: ce ne sono a non finire, conficcate sui muri delle case, spesso a segnalare la presenza di una base dell’esercito. Siamo in pieno centro urbano, e innumerevoli sbarramenti amputano spazi ed edifici strappandoli agli abitanti per cederli a coloni e soldati.
«È come benzina messa accanto a un fuoco acceso», sospira Idriss, volto incartapecorito, mani ruvide per le olive che raccoglie da alberi secolari. Queste piante raccontano di altri tempi, vecchie e rugose come il loro proprietario, sembrano fossili ancora fecondi. «Non esiste pace che sia senza libertà», ripete come un mantra, e la sua libertà, mi sussurra, è vivere nella sua terra. «Ma se tu fossi un leader, cosa faresti per risolvere questa situazione?», lo incalzo. Sorride serafico: «Io voglio essere leader solo delle mie olive».
Sono vicino a un checkpoint con un compagno dell’International Solidarity Movement, sono le sei e mezza di mattina. Stiamo controllando che i bambini e le bambine possano andare a scuola senza difficoltà causate da coloni o soldati. Gli episodi di attacchi fisici sono innumerevoli e di una violenza incredibile .
Il ragazzo in divisa nel gabbiotto dell’esercito parla italiano: «Cosa fai qua?». Mi trattengo dal chiederlo a lui, cosa diavolo ci faccia qua. «Voi non sapete niente, venite qua solo a rompre le palle…», prosegue con tono pacato. Alle sue spalle, una scritta blu sul muro: Free Israel.
Questa città è all’estremo, è un labirinto da cui è impossibile venire fuori. È in questo luogo che si mostra il volto della segregazione, eufemisticamente chiamato principio della separazione. Vige invece l’esclusione forzata di un’intera comunità, ammanettata e rinchiusa affinché evada il più lontano possibile. Per mantenere questo sistema insostenibile Israele ha disposto un controllo capillare come da nessun’altra parte: ha fatto installare telecamere persino nella moschea. Sempre in nome della propria sicurezza, questo controllo si traduce in una presenza militare costante e pervasiva, soffocante. L’esperimento, purtroppo, sta lentamente funzionando.
È in questa situazione esasperata che gli abitanti, abituati alla tragedia di cui sono attori protagonisti, decidono talvolta di lasciarsi andare alla commedia, davanti ad un buon narghilè. Si raccontano a vicenda barzellette con il sarcasmo di chi non sa se ridere o piangere.
«Un tipo gira per strada fumando due sigarette. A chi gli chiede il perché, risponde che una è per lui, mentre l’altra la fuma per suo fratello, che è in carcere da tanti anni. Pochi giorni dopo, lo vedono con una sola sigaretta in mano. «Congratulazioni», dicono tutti, «tuo fratello è libero!». Ma l’uomo, subito: «No no, sono io che ho smesso di fumare.»
«Buona, questa. Ascolta allora: ci sono due palestinesi su un’auto, uno bendato e uno ammanettato. Chi guida dei due? La polizia.»
Alla fine, si ride: anche questa è resistenza.
Handala