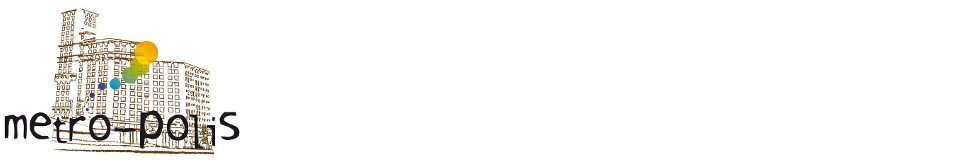“L’occidente difende se stesso se difende Israele,
se difende la sicurezza in quella parte del mondo”
(Angelino Alfano)
Quando viene annunciata la tregua a Gaza, la Cisgiordania festeggia, movimento irriflesso di un unico corpo diviso. I venditori di cahua (caffè) ne offrono bicchieri ai passanti, sorridendo, e mentre cammino per strada percepisco come una distensione di membra contratte, un sospiro generalizzato per un massacro che rimane in sospeso. Eppure, da queste parti l’entusiasmo è un fuoco di paglia, e la realtà un secchio d’acqua gelida.
Chiedo ad Abed, un amico che vive nel campo profughi di Balata, cosa ne pensa del cessate il fuoco. “Yes but no”, risponde subito: l’accordo raggiunto dovrebbe fermare lo sterminio, benissimo, ma “di promesse simili ne ho già viste tante, tutte cadute nel vuoto, di Israele non mi fido, non ha alcun interesse a mantenere la parola data”. Come dargli torto, dopo le tante speranze verso un processo di pace che ha portato invece alla progressiva normalizzazione dell’occupazione? Come pretendere fiducia, dopo una vita vissuta sotto la paura dell’esercito che entra in casa sparando e arrestando?
 Mohammad, militante storico della sinistra di Nablus, è ancora più scettico: “La tregua si fa tra eserciti di Stati in guerra, noi non abbiamo né un esercito né uno Stato. Siamo un popolo sotto occupazione che tratta con l’occupante: quale accordo è possibile tra parti così diverse?”. Sembra riecheggiare la frase di Nelson Mandela, che compare non a caso anche vicino a Betlemme, caratteri neri dipinti sul Muro dell’Apartheid: Solo gli uomini liberi possono negoziare.
Mohammad, militante storico della sinistra di Nablus, è ancora più scettico: “La tregua si fa tra eserciti di Stati in guerra, noi non abbiamo né un esercito né uno Stato. Siamo un popolo sotto occupazione che tratta con l’occupante: quale accordo è possibile tra parti così diverse?”. Sembra riecheggiare la frase di Nelson Mandela, che compare non a caso anche vicino a Betlemme, caratteri neri dipinti sul Muro dell’Apartheid: Solo gli uomini liberi possono negoziare.
“Tra i punti del cessate il fuoco non c’è nulla sui crimini di guerra di Israele, che ha massacrato intere famiglie innocenti. Non si può trattare sui morti, perché i morti restano tali, così come non possiamo decidere sulla guerra perché noi siamo sotto la guerra, da 64 anni”.
Siamo ad una piccola festicciola per il rilascio di sei ragazzi e una ragazza, arrestati giovedì scorso ad Huwwara, tutti tra i 19 e i 20 anni. L’occasione in cui ci scambiamo queste parole racchiude in sé l’ossimoro vivente che porta, da un lato, ad altisonanti dichiarazioni sulla cessazione delle ostilità, dall’altro, ad una quotidianità che rimane di violenze sistematiche. Infatti, mentre rilasciano questi sette ragazzi, Addameer (associazione palestinese per il supporto ai prigionieri e per i diritti umani) documenta più di 200 casi di arresto tra il 14 e il 22 dicembre, di cui più di 80 nelle due notti successive al cessate il fuoco. Si stima che circa il 40% degli uomini in Cisgiordania sia stato arrestato nel corso della sua vita.
Non è tutto. Mentre scrivo, c’è già un morto nella Striscia di Gaza, a Khan Younis: Anwar Abdu Hadi Qudaih, ventenne, ucciso mentre si trovava nel suo campo vicino alle recinzioni del confine.
Ma né gli arresti né questo omicidio dovrebbero sorprendere: è questa la norma, non certo l’eccezione, questo è ciò che succede tutti i giorni in West Bank come a Gaza. Forse, e solo forse, hanno smesso di bombardare, ma negli accordi non si fa parola di arresti arbitrari, omicidi, colonie in continua crescita, demolizione di case, ladrocinio di acqua risorse e terreni, mobilità negata. Il treno dell’Apartheid continua imperterrito, nessuno disturbi il conducente. Si ritorna alla routine di sempre, ma l’assenza di guerra non è pace. Se proprio volete, chiamatela pace armata.

Smoke rises after an Israeli air strike on an allegerd Hamas site in the south east of Gaza City, Gaza Strip, 17 November 2012. ANSA/MOHAMMED SABER
Solo un paio di episodi scelti a caso tra quelli avvenuti dall’inizio della tregua.
A Urif, villaggetto a sud di Nablus, la moschea è stata data alle fiamme dai coloni di Yitzhar. Questo insediamento illegale è famigerato per i suoi violenti e costanti attacchi ai Palestinesi che vivono nei dintorni, a Urif come ad ‘Asira al Qibliya e a Burin (avevo già citato questi luoghi per le violenze durante la raccolta delle olive). L’esercito israeliano è giunto sul posto poco dopo l’accaduto per sparare un po’ di lacrimogeni sulla popolazione.
A Huwwara, agglomerato di case da cui prende il nome il checkpoint delle proteste di cui ho scritto in precedenza, il 21 Novembre tre contadini (tra i quali un diciottenne) sono stati sequestrati da alcuni coloni e consegnati all’esercito, mentre lavoravano intorno ai loro ulivi.
La manifestazione del Venerdì a Nabi Saleh oggi ricordava il martire Rushdi Tamimi, morto lunedì per le ferite riportate due giorni prima. L’allucinante dinamica della vicenda appare evidente in questo filmato. Lascia senza parole il tentativo dei soldati di allontanare la madre dal ragazzo morente, minuti preziosi perduti per la cecità di individui addestrati ad obbedire e nient’altro.
È anche questo che urlavano loro in ebraico degli attivisti israeliani, durante la manifestazione di oggi. La risposta è sempre la stessa: lacrimogeni, rubber bullets, skunk water (un liquido putrido sparato con l’idrante che lascia un odore nauseabondo per giorni e giorni). Alla fine, due sono i ragazzi arrestati, entrambi israeliani antisionisti. La colonia di Hallamish è al sicuro, con le sue belle villette a schiera e i prati all’inglese, un piano urbanistico visibilmente artificioso che ghigna in faccia ai Palestinesi di Nabi Saleh, a poche centinaia di metri di distanza. Ma loro non ridono: la loro fonte d’acqua, simbolo del villaggio, sta dietro alle recinzioni protette dalle jeep dell’esercito.
“Mantenere l’ordine”, ripetono fonti militari, uno slogan ribadito in tutte le occasioni, la colonna sonora della paura distillata in televisione, per radio, sui giornali. Ma quale ordine si vuole salvare? L’ordine della prigione, della repressione, del colonialismo che non muore mai. L’ordine della violenza su ogni livello della vita, una violenza che è arbitraria e premeditata allo stesso tempo. L’ordine di sparare e uccidere chi non si sottomette. L’ordine dato ai soldati che eseguono, obbedienti e ordinati.
Palestina Occupata,
Venerdì 23 Novembre 2012,
Handala