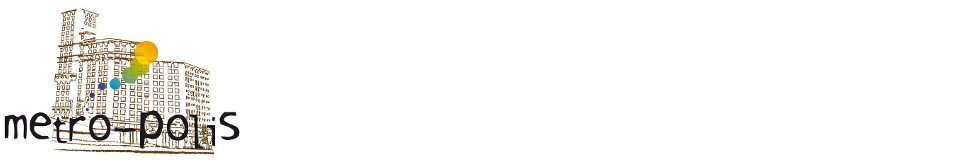Sono in un appartamento di Tel Aviv. Seduti davanti a me ci sono Tom e Schlomo, due giovani attivisti israeliani. Discutiamo da un’ora su ciò che meno conosco e comprendo, ovvero il punto di vista israeliano sull’occupazione. Occupazione che viene ridotta, anche lessicalmente, a conflitto, termine che suggerisce uno scontro tra attori sullo stesso piano. Alla fine, poi, il conflitto stesso viene normalizzato, diventa una quotidianità indifferente e allo stesso tempo si allontana, si fa silenzioso, viene digerito e interiorizzato.
L’intera società israeliana è pervasa dalla guerra, anche al suo interno. Il militarismo è l’altra faccia del sionismo. La mobilitazione totale ne è condizione necessaria. Schlomo racconta: «L’esercito è una presenza costante agli occhi dei bambini. Ricordo un gioco, alla materna, che consisteva nel collegare un’immagine ad un’altra immagine della stessa categoria. C’era un fucile disegnato, e bisognava tracciare una riga che portasse ad una colomba o ad un ramo d’ulivo. Alle elementari invece ci facevano scrivere letterine di ringraziamento ai soldati, e preparavamo per loro dei dolcetti da portare in caserma. Alle superiori spesso il supplente era una soldatessa che ci raccontava l’importanza e la bellezza di servire il proprio Paese».
Prosegue Tom: «L’esercito è la cosa più sacra, è intoccabile, non si può criticarlo in nessun modo. Ancora oggi, gli obiettori di coscienza possono evitare la leva obbligatoria solo per ragioni di salute o di salute mentale. Sennò vai in carcere, finché non vieni considerato non idoneo al servizio militare. Senza contare le pressioni familiari e sociali che devi subire se decidi di non prendere parte alle politiche di questo Stato di Apartheid».
Insisto, chiedo come sia possibile questo consenso così ampio intorno ad un disegno criminale che va avanti, imperterrito, da decenni. Tom ha una sua tesi al riguardo: «C’è un lavaggio del cervello costante che sfrutta il concetto di sicurezza. Parlare di continuo di sicurezza fa nascere la paura, e con la paura si può fare di tutto». Mi cita una frase attribuita nientemeno che a Herman Goering: «Ovviamente, la gente non vuole la guerra. Perché mai un contadino pezzente dovrebbe rischiare la vita in guerra quando il massimo che ne può ottenere è tornare alla sua fattoria tutto intero? Naturalmente, la gente comune non vuole la guerra; né in Russia, né in Inghilterra, né America, e per quello neanche in Germania. Questo è ben chiaro. Ma, dopo tutto, sono i capi della nazione a determinarne la politica, ed è sempre piuttosto semplice trascinare la gente dove si vuole, sia all’interno di una democrazia, che in una dittatura fascista o in un parlamento o in una dittatura comunista. […] La gente può sempre essere condotta ad ubbidire ai capi. È facile. Si deve solo dirgli che sono attaccati e accusare i pacifisti di mancanza di patriottismo e di esporre il paese al pericolo. Funziona allo stesso modo in qualunque paese».
 Non basta. Tom aggiunge, con voce ferma, che «in realtà la maggior parte degli Israeliani non è estremista come i coloni. È solo apatica: gli Israeliani impiegano moltissime fatiche e sforzi continui nel non volere vedere». Schlomo mi racconta allora della sua personale presa di coscienza: «Sono nato in kibbutz. Tutti erano molto militaristi e molto sionisti, lì dentro. Un giorno, ero ancora un bambino, vidi un villaggio abbandonato, poco lontano dal mio kibbutz. Cominciai a chiedere in giro perché quelle case fossero vuote, sembrava che non ci vivesse nessuno da decine d’anni. Nessuno mi rispondeva, sviavano le mie domande o mentivano. Fu allora che compresi che c’era qualcosa di nascosto, qualcosa di cui non si poteva parlare. Quello era uno dei villaggi ripuliti durante la Nakba, i cui abitanti e i loro discendenti vivono, forse, in un campo profughi da qualche parte, senza poter ritornare». Continue reading
Non basta. Tom aggiunge, con voce ferma, che «in realtà la maggior parte degli Israeliani non è estremista come i coloni. È solo apatica: gli Israeliani impiegano moltissime fatiche e sforzi continui nel non volere vedere». Schlomo mi racconta allora della sua personale presa di coscienza: «Sono nato in kibbutz. Tutti erano molto militaristi e molto sionisti, lì dentro. Un giorno, ero ancora un bambino, vidi un villaggio abbandonato, poco lontano dal mio kibbutz. Cominciai a chiedere in giro perché quelle case fossero vuote, sembrava che non ci vivesse nessuno da decine d’anni. Nessuno mi rispondeva, sviavano le mie domande o mentivano. Fu allora che compresi che c’era qualcosa di nascosto, qualcosa di cui non si poteva parlare. Quello era uno dei villaggi ripuliti durante la Nakba, i cui abitanti e i loro discendenti vivono, forse, in un campo profughi da qualche parte, senza poter ritornare». Continue reading